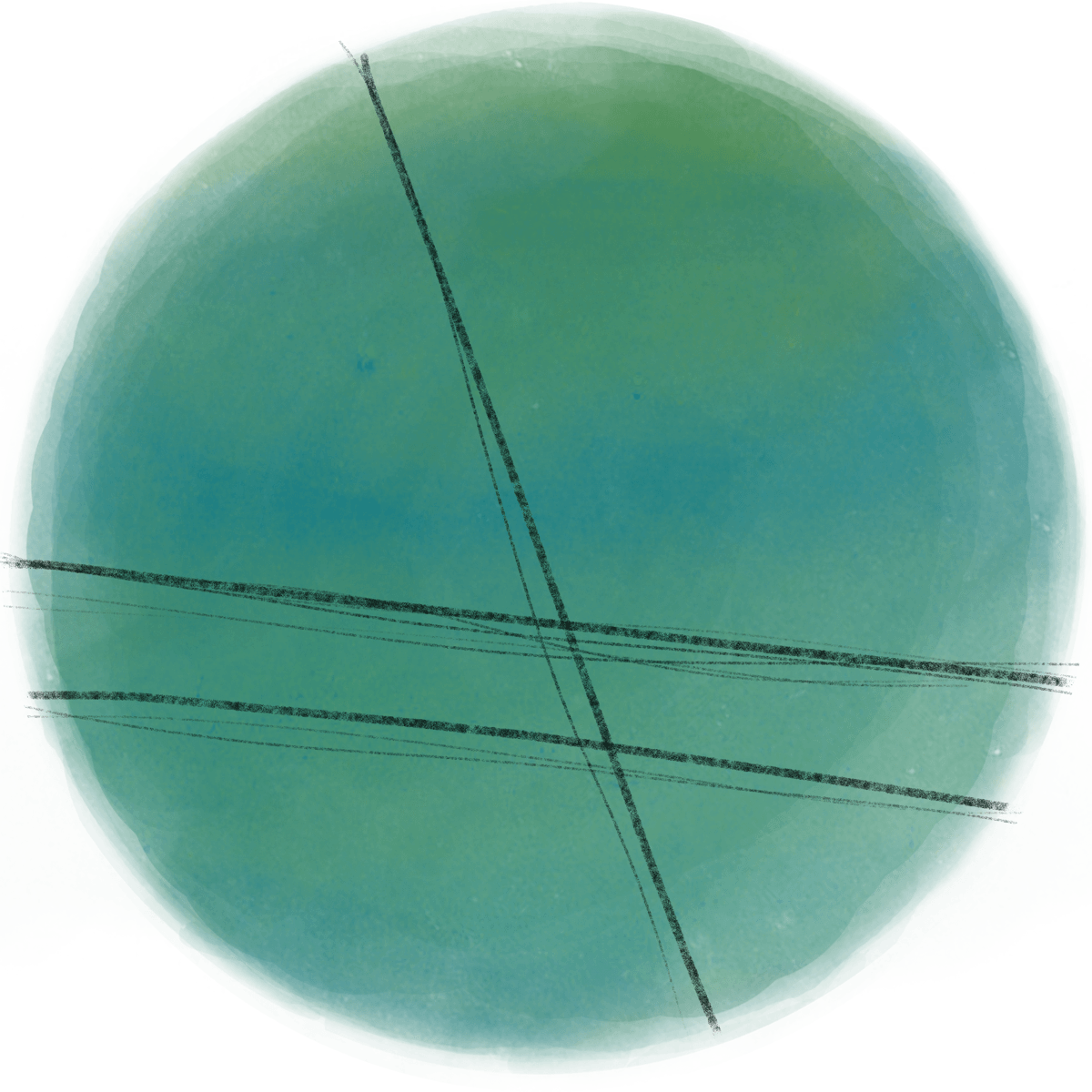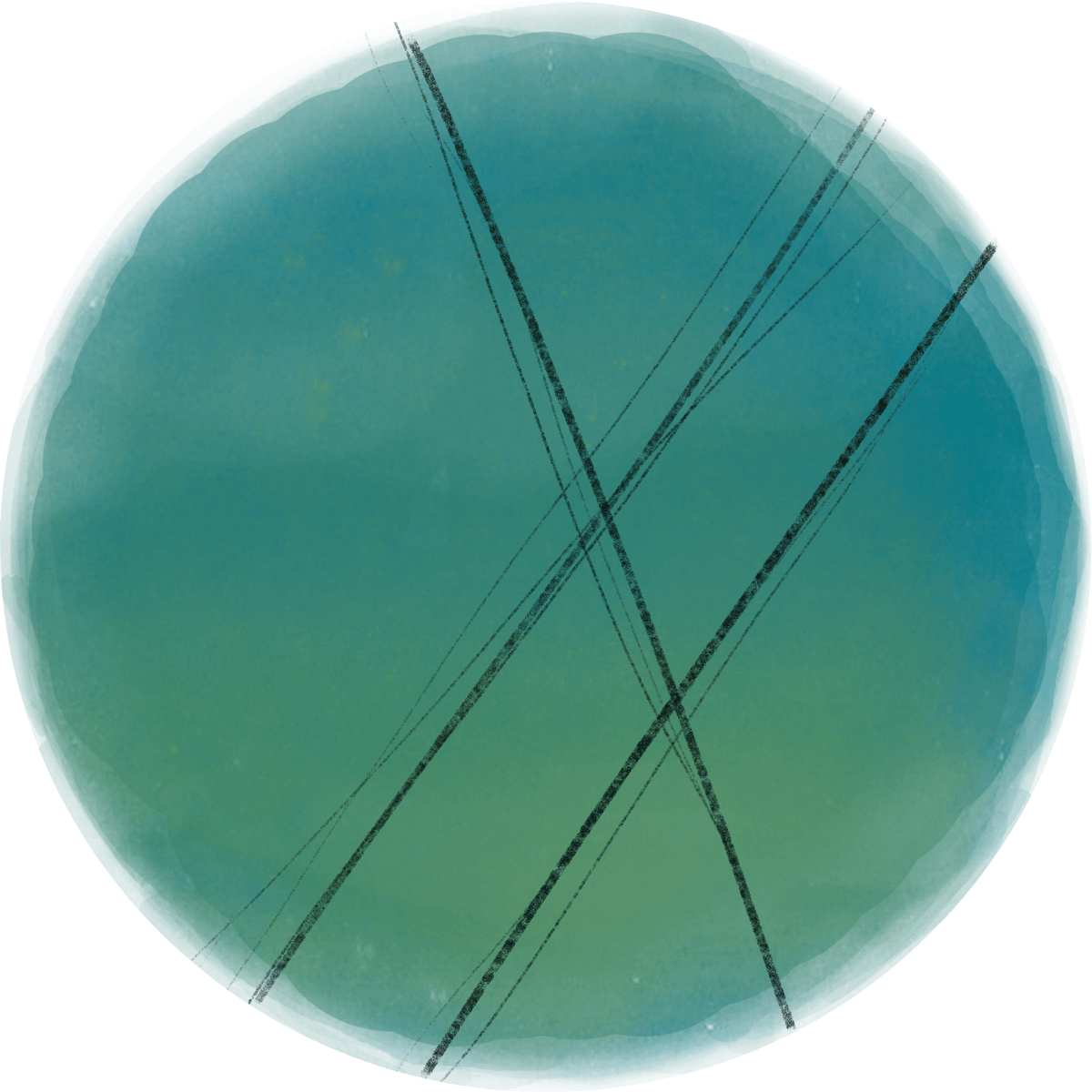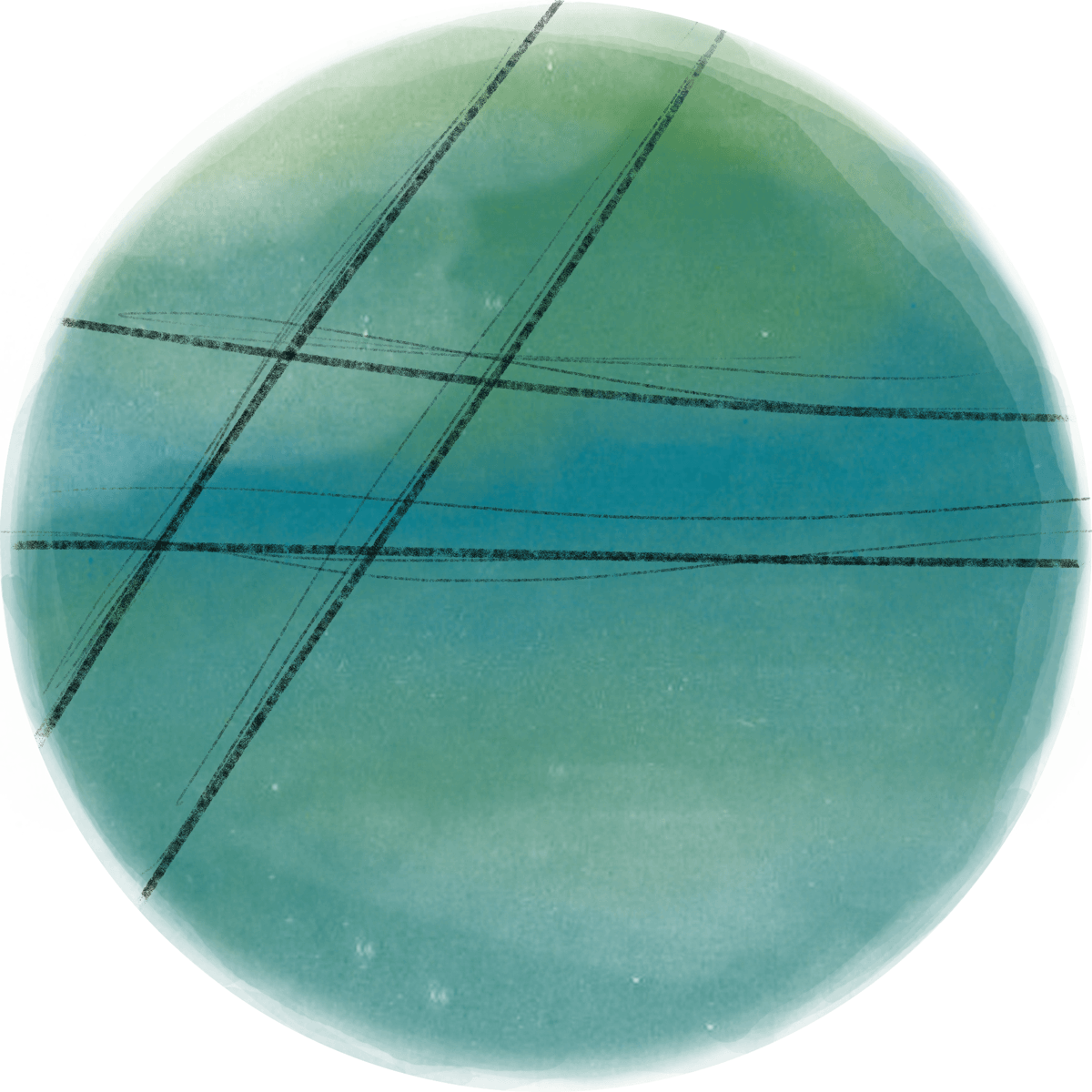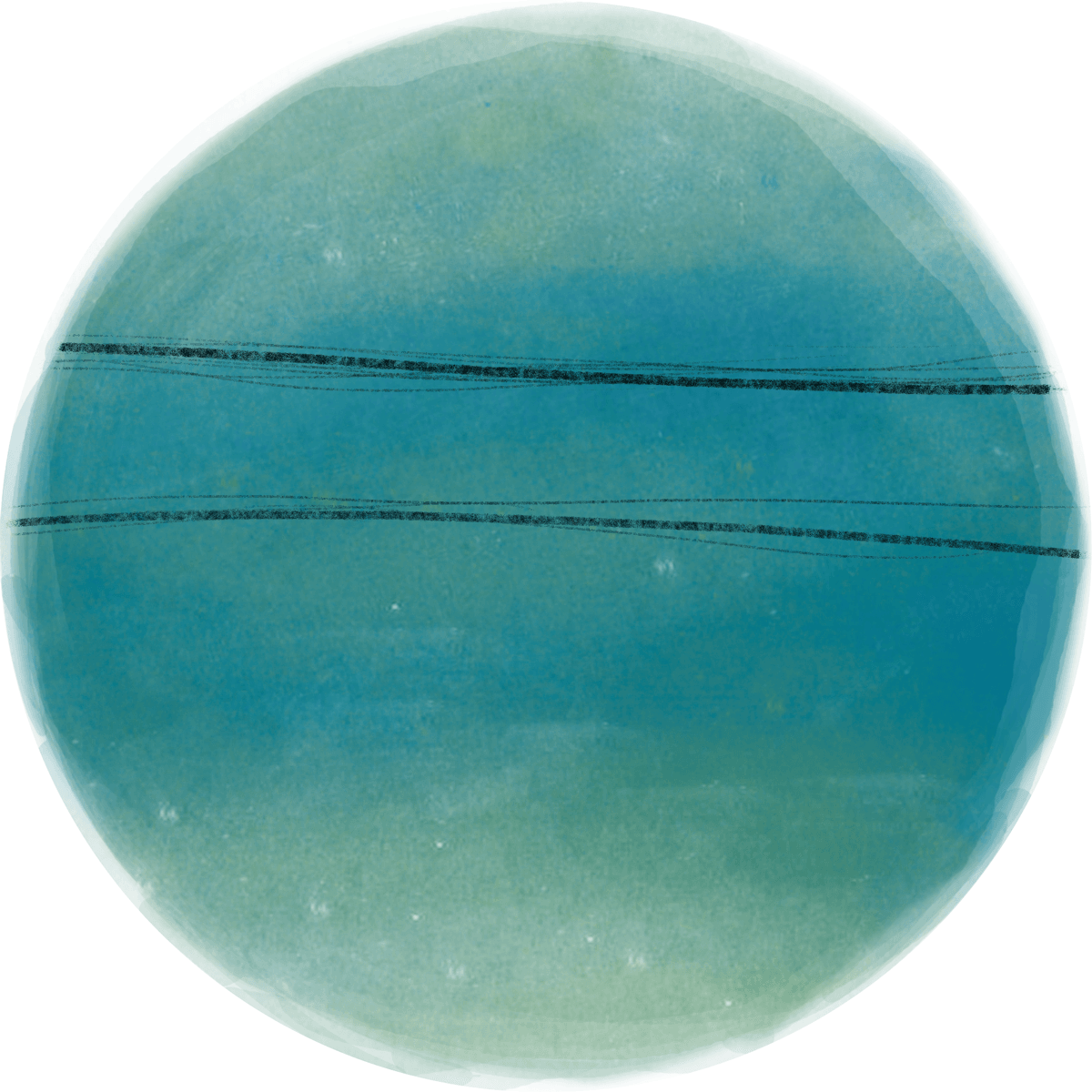19 Giugno 2020
Essere colpiti dalla malattia
Le sfide che la malattia organica pone ad individuo e famiglia

Viviamo in un periodo storico e culturale in cui grande attenzione viene rivolta alla salute e al modo in cui è possibile preservare se stessi dalla malattia; lo notiamo osservando le tante notizie e pubblicità sulla salute e le possibili cure ed ogni qual volta si insiste sull’importanza della prevenzione. Negli ultimi mesi, inoltre, la pandemia da COVID-19 ha reso tanto più evidente quanto la malattia possa sconvolgere la vita di intere collettività e l’importanza di adottare tutte le misure possibili per prevenirla e prendersene cura.
Nel corso del Novecento e degli ultimi decenni, grazie al diffondersi di migliori condizioni di vita e all’ampliarsi delle conoscenze scientifiche, della cultura medica e psicologica, è stato possibile osservare quanto l’insorgere di una malattia possa condizionare l’esperienza della persona. Proprio su questo aspetto intendiamo concentrarci, cioè sul modo in cui l’esperienza di malattia ed il conseguente percorso di cura possono toccare l’esistenza dell’essere umano e del suo gruppo familiare.
Per iniziare possiamo soffermarci su che cosa sia la malattia. Il dizionario Treccani la definisce come la “condizione abnorme e insolita di un organismo vivente, animale o vegetale, caratterizzata da disturbi funzionali, da alterazioni o lesioni – osservabili o presumibili, locali o generali – e, nel caso di animali a elevata organizzazione nervosa, da comportamenti inconsueti riconducibili a sofferenza psicofisica (nel caso specifico dell’uomo si considera la mutata percezione dello stato del proprio corpo, o cenestesi, che può assumere l’intensità dell’allarme da pericolosità per la sopravvivenza).”
Molteplici sono le patologie che possono colpire l’individuo, alcune acute, altre croniche; possono coinvolgere diversi organi o apparati, con decorso, sintomatologia e prognosi molto vari. Nella propria esistenza, ad esempio, la persona può imbattersi in malattie cardiovascolari e/o metaboliche, in una malattia renale, in patologie neurologiche od oncologiche di vario tipo. Tali condizioni cliniche, particolarmente impattanti sulla vita, vengono definite malattie ad elevato carico emotivo, per metterne in luce gli importanti risvolti emotivi, psicologici e di impatto sull’esistenza.
È importante notare, infatti, che le patologie organiche, sebbene implichino in primo luogo il corpo della persona, alterandone le funzioni o provocando lesioni, sono condizioni particolarmente stressanti che coinvolgono in realtà il complesso dell’esperienza individuale, chiamando in causa molteplici aspetti.
La malattia può condizionare la psiche della persona, in quanto possono nascere particolari paure, ansie e aspettative; impone di venire a patti ed accettare la realtà, sollecita la capacità di adattarsi alle condizioni imposte dalla malattia stessa, che l’individuo può essere in grado o meno di realizzare anche in funzione delle proprie caratteristiche personali. La malattia, inoltre, impone di provare ad affidarsi alle cure dei professionisti sanitari, implicando la capacità di fiducia e collaborazione con l’équipe curante.
Viene chiamata in causa anche la storia di vita della persona: il momento della vita in cui la malattia insorge, l’aver affrontato in passato (direttamente o indirettamente) esperienze simili, i personali impegni lavorativi, familiari o sociali, sono fattori che possono influenzare il modo in cui l’individuo vive l’esperienza di malattia e riesce ad affrontarla.
Pure gli affetti vengono implicati in vario modo: l’insorgere della malattia può attivare i famigliari e le persone vicine che prestano le loro cure con sollecitudine e per il tempo necessario in funzione dell’andamento delle condizioni cliniche; l’età dei congiunti, la loro capacità di comprendere la situazione e di gestirla, sono importanti e possono influenzare il modo in cui viene vissuta l’esperienza di malattia.
Il momento storico è un altro fattore importante: il modo in cui la società concepisce la malattia e la cura, le conoscenze scientifiche, gli strumenti medici e terapeutici a disposizione, il modo in cui è necessario riorganizzare la propria quotidianità per curarsi sono fattori importanti che possono impattare sull’andamento e sull’esperienza di malattia e di cura.
Ultimo, ma non in termini di importanza, fattore implicato dall’esperienza di malattia consiste nella possibilità di cambiamento, cioè nelle concrete possibilità di curarsi, di guarire e di poter ritornare ai propri ruoli sociali, lavorativi ed affettivi senza dover troppo risentire dello stigma della malattia, senza doversi vergognare e potendo ancora sentirsi se stesso, non troppo cambiato dalla malattia.
Con il miglioramento delle conoscenze e degli strumenti scientifici e medici, è nettamente migliorata la possibilità di accedere alle cure per le varie patologie organiche e, salvo in alcuni casi, sono cresciute le possibilità di sopravvivenza o di guarigione. Si tratta di risultati ovviamente incoraggianti, che aprono alla necessità di riflessione su alcuni importanti aspetti. Riflessione che riguarda non solo i professionisti sanitari, ma ogni singola persona, in quanto detentrice di valori e di una propria visione della vita, della salute e della malattia.
Le maggiori possibilità di sopravvivenza impongono di prestare un’attenzione sensibile al tema della qualità di vita di cui la persona stessa può beneficiare: è importante che l’individuo senta di potere godere di un’esistenza dignitosa e soddisfacente; nel caso in cui la patologia comporti un’alterazione persistente delle condizioni fisiche, psicologiche o di vita, è fondamentale che la persona abbia la possibilità di adattarsi ed imparare a convivere con le proprie condizioni, nell’ottica del raggiungimento di una qualità di vita soddisfacente. Inoltre, è opportuno prendere in considerazione il modo in cui la malattia impatta sui ruoli sociali dell’individuo, che può sentire alterato il proprio essere lavoratore, genitore, coniuge, figlio, fratello o sorella o amico/a, per l’ingombrante presenza del nuovo ruolo di malato che si impone nella sua esistenza. È fondamentale che in primo luogo i professionisti sanitari ma in generale tutti prestino attenzione e problematizzino questi aspetti dell’esperienza di malattia, perché possono influenzare in modo notevole l’esperienza della persona malata e della sua famiglia.
Le reazioni psicologiche alla malattia

L’insorgere di una patologia e la comunicazione della sua diagnosi assai frequentemente sono un evento decisamente stressante per la persona che vive questa condizione.
La comunicazione della diagnosi, in particolare, è un momento molto delicato, in cui la persona scopre le proprie condizioni cliniche ed entra in contatto con la propria fragilità e vulnerabilità; proprio per la portata emotiva ed esistenziale che la notizia comporta, è necessario che il professionista presti particolare attenzione al modo in cui la notizia viene data e in cui la persona la recepisce e vi reagisce.
Come abbiamo visto, la malattia può alterare il corso di vita, condizionandone diversi aspetti ed imponendo la necessità di trovare un adattamento alla nuova condizione. Nella sua globalità, nel corpo, emotivamente e nelle relazioni sociali, l’individuo si attiva per reagire e ristabilire un equilibrio che lo faccia stare bene.
Le reazioni psicologiche alla malattia sono molteplici, variano in funzione del tipo di patologia, degli organi o delle funzioni coinvolti, delle caratteristiche psicologiche e di personalità dell’individuo, della qualità delle relazioni sociali e del sostegno che percepisce da parte delle persone vicine. Considerata questa grande variabilità, prendiamo in analisi alcune delle principali tematiche e dei vissuti che si presentano più spesso.
L’avere una malattia può mettere la persona in contatto con la propria vulnerabilità e fragilità, facendo crollare quel senso personale di forza o quasi di onnipotenza che assai spesso porta a ritenere che gli eventi di vita spiacevoli possano riguardare l’altro ma non se stessi. Tali vissuti di vulnerabilità possono essere molto dolorosi ed esporre al rischio di sviluppare vissuti di perdita di controllo o di impotenza che fanno sentire la persona inerme di fronte agli eventi della vita.
I vissuti di vulnerabilità ne richiamano un altro, talvolta dominante: la paura della morte, che la malattia suscita in modo quasi immediato e più o meno consapevole. Riguarda la paura di un annientamento fisico, in quanto la malattia minaccia l’incolumità fisica della persona, che teme che la propria esistenza possa concludersi imponendo il distacco da tutte le relazioni importanti, lasciando in sospeso i propri progetti e precludendo il futuro. Ma riguarda anche la paura di un annientamento psichico, in quanto può insorgere una reazione emotiva tanto immediata quanto intensa di disorientamento e di confusione, che mette in discussione la propria identità e la propria capacità di sentirsi adeguati per adempiere al proprio ruolo di lavoratore, genitore, famigliare, uomo o donna.
Alla paura della morte si collega l’incertezza sul futuro, perché la malattia può far rimettere in discussione i propri progetti, le proprie aspirazioni e soprattutto le proprie sicurezze. Questo è tanto più vero quando la prognosi è incerta e quando vengono imposte restrizioni alla propria autonomia personale; in questo caso possono insorgere sentimenti intensi di ansia, di angoscia o di disperazione che accentuano la sofferenza personale.
Un altro nodo importante è quello del dolore: può essere un’eventualità che si prende in considerazione e spaventa oppure una realtà che la persona vive ed è necessario che impari a gestire, sia con l’aiuto delle terapie sia attingendo alle proprie risorse personali. Anche il dolore fisico può suscitare una costellazione importante di emozioni dolorose, come ansia, impazienza, irritazione, tristezza, spossatezza fino alla depressione, che rischiano di complicare la situazione ed intaccare notevolmente la qualità di vita.
Alterando il funzionamento e l’integrità dell’organismo, la malattia può provocare cambiamenti nel rapporto della persona con il proprio corpo: questo, infatti, viene più o meno visibilmente ferito, mutato ed alterato sia dalla malattia sia dagli interventi terapeutici necessari. A tali cambiamenti fisici si accompagnano assai spesso sentimenti più o meno intensi, che hanno a che fare con la fragilità, la vulnerabilità, il senso di perdita, un possibile senso di tradimento da parte del proprio corpo e con il significato simbolico che la persona attribuisce alla zona o all’organo coinvolti dalla malattia. È importate prestare un’attenzione sensibile ai mutamenti corporei e al modo in cui viene vissuto il rapporto con il proprio corpo per prevenire l’insorgere di sentimenti di estraneità e di alienazione rispetto al proprio corpo ed in ultima istanza rispetto a se stessi.
Quelli descritti fin qui sono i principali nodi emotivi che possono presentarsi con l’insorgere di una malattia che mette in crisi il ciclo di vita della persona. Ovviamente, i vissuti individuali non saranno immutabili lungo il percorso di malattia e di cura, ma fluiranno in sintonia con le varie fasi di malattia e terapia. In particolare, il periodo degli accertamenti e della comunicazione della diagnosi è quello più delicato per il paziente e per la sua famiglia, che possono vivere profondi stati d’ansia, di incertezza e tensione e possono ricorrere a difese di negazione ed evitamento per difendersi da una sofferenza troppo intensa; sarà responsabilità dei curanti accompagnare in modo sensibile il malato e la sua famiglia a prendere gradualmente consapevolezza della realtà e delle possibilità che si dispiegano, per effettuare in modo condiviso una scelta consapevole rispetto alle prospettive terapeutiche.
Il modo in cui la persona reagisce alla malattia è influenzato, in particolare, da due fattori importanti. Il primo consiste nel tipo di strategia di coping adottata, ossia quella serie strategie ed azioni attuate per gestire le situazioni critiche, difficili o stressanti. Nel caso dell’insorgere di una malattia, più frequentemente si possono osservare 4 tipi di strategie:
- Disperazione ed impotenza: in questa modalità di reazione prevalgono sentimenti di ansia e depressione, la persona percepisce di non avere il minimo controllo della situazione (tutto viene deciso dal destino, dal caso), non riesce a mettere in atto strategie cognitive e comportamentali che la aiutino ad accettare e fronteggiare la malattia, a dare un significato ad essa e alla vita.
- Spirito combattivo: la persona che adotta questa strategia mostra sentimenti di ansia e depressione moderati, percepisce di poter controllare almeno in parte la propria situazione e si mostra capace di accettare la malattia, attribuirle un significato e cercare di ridurre il suo impatto sulla propria vita; rimane possibile rivolgere uno sguardo positivo all’esistenza e al futuro.
- Negazione ed evitamento: la persona non mostra sentimenti ansiosi o depressivi, minimizza la portata emotiva degli eventi, non si attiva per cercare informazioni ed attribuire un proprio significato alla malattia, nutre la convinzione di controllo sia interno sia esterno sulla situazione, anche al di là del principio di realtà.
- Accettazione stoica: con questa strategia, l’individuo mostra bassi livelli di ansia e depressione ed un elevato fatalismo, attribuendo all’esterno la possibilità di controllo della propria situazione (il mio presente e futuro dipendono dal caso, dal fato, dalla Provvidenza, dal comportamento ostile o benevolo delle altre persone…); egli assume un atteggiamento passivo e poco motivato nei confronti del percorso di cura.
Il secondo fattore che influenza la reazione della persona alla malattia consiste nella percezione o meno di avere il controllo sugli eventi, cioè il locus of control; si parla di locus of control interno quando l’individuo percepisce di essere responsabile di ciò che accade, e di poter controllare almeno in parte gli eventi che costellano la sua vita. Quando invece prevale un locus of control esterno la persona percepisce che gli eventi siano causati da fattori indipendenti dalla propria responsabilità (il fato, il caso) e di non poter intervenire su di essi.
La presenza di un basso locus of control esterno e la percezione di un adeguato supporto sociale, cioè della vicinanza e del sostegno di persone care, permettono alla persona di adottare un atteggiamento combattivo verso la malattia, cioè di percepirla come una sfida a cui è possibile fare fronte in modo attivo.
Il modo in cui la persona reagisce e riesce ad adattarsi alla malattia e alle terapie può essere quindi influenzato da molti fattori, alcuni individuali hanno a che fare con le personali risorse psicologiche ed emotive, altri hanno a che fare con il contesto e con la rete di relazioni di cui si dispone.
Il primo importante fattore consiste nel tipo di patologia e nelle sue caratteristiche (sintomatologia, decorso, prognosi, terapie, dolore) che possono rendere più o meno facile attingere alle proprie risorse per reagirvi. È poi importante il significato esistenziale che la persona riesce ad attribuire alla malattia, che può alimentare la combattività oppure l’impotenza dell’individuo: la malattia può essere considerata una sfida, un nemico, una punizione, un segnale dell’indebolimento del proprio organismo, qualcosa di cui vergognarsi o una perdita della propria identità. Sulle capacità di adattamento incidono, inoltre, l’equilibrio psicologico o il livello di fragilità che connotavano la persona prima dell’insorgere della malattia (età, livello di maturazione psicologica, caratteristiche di personalità, eventuali psicopatologie), i fattori culturali e spirituali (influenzano la capacità di attribuire un significato alla malattia, la percezione del dolore e la possibilità di mantenere un sufficiente livello di benessere e qualità di vita) e la qualità del sostegno sociale percepito (ossia la possibilità di sentirsi sostenuto/a da persone vicine e fidate).
Le reazioni familiari alla malattia

Se è vero che la malattia può essere un evento estremamente stressante per l’individuo che ne è colpito, è altrettanto vero che egli è inserito in un contesto sociale e familiare. Prendiamo in considerazione in particolar modo la famiglia, il gruppo di persone più vicine ed intime a cui di solito si fa maggiormente riferimento, e osserviamo che la malattia non incide solo sull’esistenza del singolo, ma anche su quella della famiglia, che con ogni probabilità vedrà alterati i propri equilibri, il proprio benessere e le proprie possibilità a seguito della patologia.
Il modo in cui la famiglia reagirà alla malattia di un proprio membro, ovviamente, può cambiare in funzione di diversi fattori: il tipo di malattia, quale membro della famiglia si è ammalato, la struttura e l’organizzazione familiare, il momento del ciclo di vita familiare in cui è insorta la malattia e via così. Notiamo, ad esempio, quanto possono essere diverse queste situazioni, anche nelle ripercussioni: quando si ammala una donna single e madre di uno o più adolescenti, il figlio neonato di una giovane coppia, un uomo padre di due figli adulti o il partner di una famiglia senza figli.
Anche in questo caso, tuttavia, possiamo fare alcune riflessioni generali che accomunano la maggior parte delle situazioni.
Quando un membro della famiglia si ammala, è assai frequente che l’intera famiglia si attivi per aiutare colui o colei che attraversa un periodo di fragilità, in modo partecipe o addirittura con abnegazione. Accade che la famiglia si stringa nel tentativo di prestare le migliori cure possibili al congiunto, di proteggerlo e tutelarne la salute. Si tratta di un movimento fisiologico, di protezione, funzionale nella misura in cui si mantiene un equilibrio soddisfacente tra lo stringersi in soccorso della persona malata e la possibilità per ciascuno di conservare propri spazi di autonomia personale e cura di sé; è anche importante che la famiglia, nello stringersi in soccorso, non finisca per chiudersi nei confronti dell’esterno, ma continui a coltivare relazioni sociali significative.
Se la persona malata può sviluppare molteplici paure, sentimenti di impotenza e perdita di controllo, parallelamente i famigliari possono nutrire paure intense per l’incolumità del congiunto e angosce di morte particolarmente forti. Possono sviluppare sentimenti di impotenza e di rabbia perché sentono di non avere il controllo su ciò che accade alla propria famiglia e alla persona cara.
In alcune circostanze, la persona malata può sviluppare sentimenti di colpa anche molto intensi, per essersi ammalata, perché necessita dell’aiuto e dell’assistenza dei famigliari, e perché sollecita il cambiamento delle abitudini della propria famiglia in quanto non riesce a svolgere il proprio ruolo ed i propri compiti come prima. Tali cambiamenti possono anche spaventare la persona che può percepire che la propria famiglia non riuscirà a farvi fronte (mi sono sempre occupato/a di tutto io, come sarà possibile proseguire?).
Talvolta, la reazione della persona malata consiste nel tentativo di tenere per sé la propria sofferenza, spingendosi oltre le proprie capacità al fine di non dare un ulteriore peso alle persone vicine. In queste situazioni ella non parla ai famigliari della propria malattia, la nasconde tentando di farvi fronte da sola e portando avanti le proprie abituali attività. Si tratta, però, di una strategia estremamente dannosa e fallimentare, perché impone all’individuo di dover tollerare due pesi enormi: quello del dover affrontare da solo la malattia, le cure ed i vissuti connessi e l’ulteriore peso di non poter comunicare con i propri cari, di non poter condividere con loro i propri vissuti, piacevoli e spiacevoli, privandosi così del loro sostegno e della loro vicinanza. Questo comporta spesso vissuti di isolamento, di solitudine e rischia di separare la famiglia: non solo la persona malata può sentirsi sola e fragile, ma anche i famigliari possono sentirsi esclusi, impotenti e soli nel vedere il proprio caro affrontare da solo una situazione così difficile.
In numerose situazioni, la famiglia può reagire ai complessi vissuti attivati dalla malattia alterando le proprie capacità di comunicazione e vicinanza: può accadere, infatti, che tutti siano al corrente della situazione delicata e che si attivino per aiutare il famigliare ad affrontare il percorso di malattia e di cura. Tuttavia, talvolta si tende a non parlare della malattia e della sofferenza che essa comporta, nel tentativo di non accentuare il dolore del congiunto, di aiutarlo a farsi forza e a superare in modo più rapido la malattia ed i vissuti dolorosi. Sebbene nella maggior parte dei casi adottata con le migliori intenzioni, tale strategia rischia di rivelarsi controproducente: esprimere e condividere la sofferenza spesso fa paura, si teme di non riuscire a gestirla e che essa aumenti e generi altra sofferenza. In realtà non è così: la persona malata nella maggior parte dei casi sente il bisogno di esprimere la propria sofferenza, di condividerla e di sentire che essa può incontrare la comprensione ed il conforto delle persone care. Questo dà conforto ed aiuta ad alleviare la sofferenza. Allo stesso tempo, anche per i famigliari la condivisione autentica della sofferenza, la possibilità di dare e ricevere un conforto rendono possibile prendersene cura ed alleviarla. L’impossibilità di parlare, di condividere sentimenti ed emozioni, di sentirsi compresi e sostenuti rischia invece di accentuare la sofferenza stessa e di alimentare sentimenti di isolamento, incomprensione e solitudine.
Quali prospettive terapeutiche?

Come abbiamo visto, le persone e le famiglie travolte da una malattia sono vulnerabili e corrono il rischio di sviluppare una maggiore sofferenza emotiva. Questo è normale, fa parte del corso della vita e non comporta necessariamente che si sviluppino problemi psicologici o relazionali.
Se sviluppare una malattia è un evento critico, un fattore di rischio per la nascita di un malessere psicologico e/o relazionale, esistono vari fattori protettivi che contribuiscono a salvaguardare il benessere della persona e della famiglia. Alcuni di essi consistono nella percezione di conservare un certo controllo e responsabilità sulla situazione in cui ci si trova coinvolti, la possibilità di sentirsi sostenuti da una rete sociale pronta a dare supporto e la possibilità di mantenere spazi personali di autonomia e svago.
Talvolta, purtroppo, il ricorso alle proprie risorse personali e sociali non è sufficiente e la persona o la famiglia possono sviluppare un certo malessere emotivo o relazionale, che va ad aggravare lo stato di salute già compromesso; possono svilupparsi, ad esempio, sintomi d’ansia o depressivi, sintomi da stress post-traumatico, disturbi del sonno o dell’alimentazione.
Nel caso in cui la sofferenza emotiva o relazionale sia particolarmente intensa, può essere utile ricorrere ad un supporto specialistico, rivolgendosi ad uno psicologo o psicoterapeuta che sarà in grado di accogliere la persona malata o i famigliari, comprendere, dare credito e contenere la sofferenza in tutta la sua complessità, al fine di migliorare il benessere e la qualità di vita della persona e della famiglia.
Laddove si siano create delle difficoltà relazionali in conseguenza dello stravolgimento provocato dalla malattia, sarà possibile intervenire per facilitare le comunicazioni, renderle più chiare, coerenti ed empatiche, abbassando il livello di conflittualità laddove sia elevato.
Sono molteplici le vie terapeutiche possibili ed efficaci nei vari casi: in alcuni è più indicata una psicoterapia individuale, in altri una psicoterapia familiare, in altri ancora una psicoterapia di gruppo. Particolarmente utile può essere l’utilizzo della terapia EMDR per prendersi cura dei vissuti traumatici connessi alla malattia; la mindfulness può aiutare a rientrare in contatto con il proprio corpo riscoprendo le sue possibilità, la capacità di prendersi cura di sè e la possibilità di sentirsi in equilibrio. Possono, inoltre, rivelarsi utili le tecniche di rilassamento e le terapie espressive come l’arteterapia, la musicoterapia o la danzaterapia.
Bibliografia
- Crotti, N. and G. Scambia (2005). Psiconcologia della famiglia. Milano, Poletto Ed.
- Fischer, G. N. (2006). Trattato di psicologia della salute, Borla.
- Torta, R. and A. Mussa (2007). Psiconcologia. Il modello biopsicosociale, Centro Scientifico Editore.
- Vannotti, M., M. Gennart, et al. (2018). Corpi e storia di vita. La sfida della malattia cronica, Alpes Italia
Contatti
Chiama
Scrivi
Mi trovi in