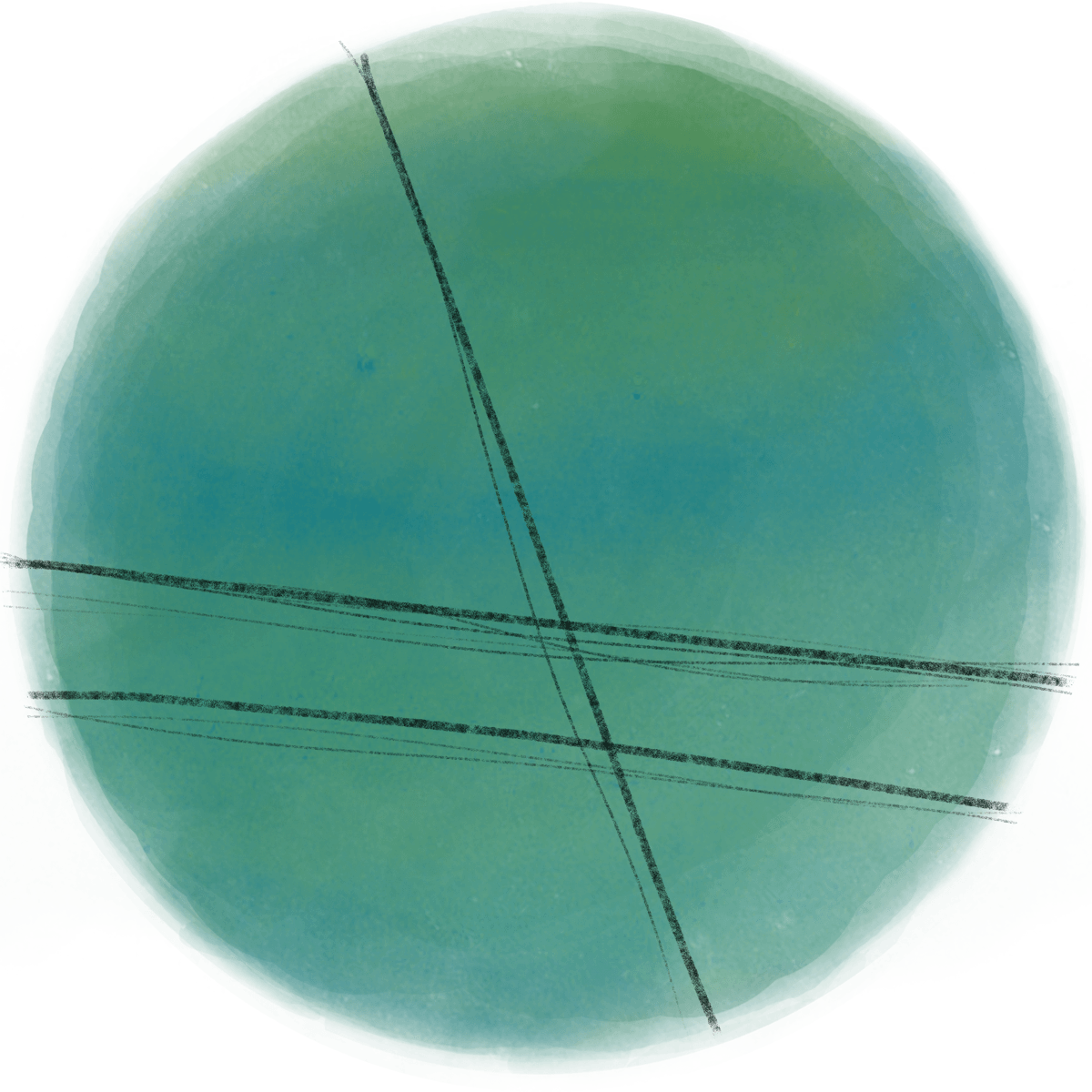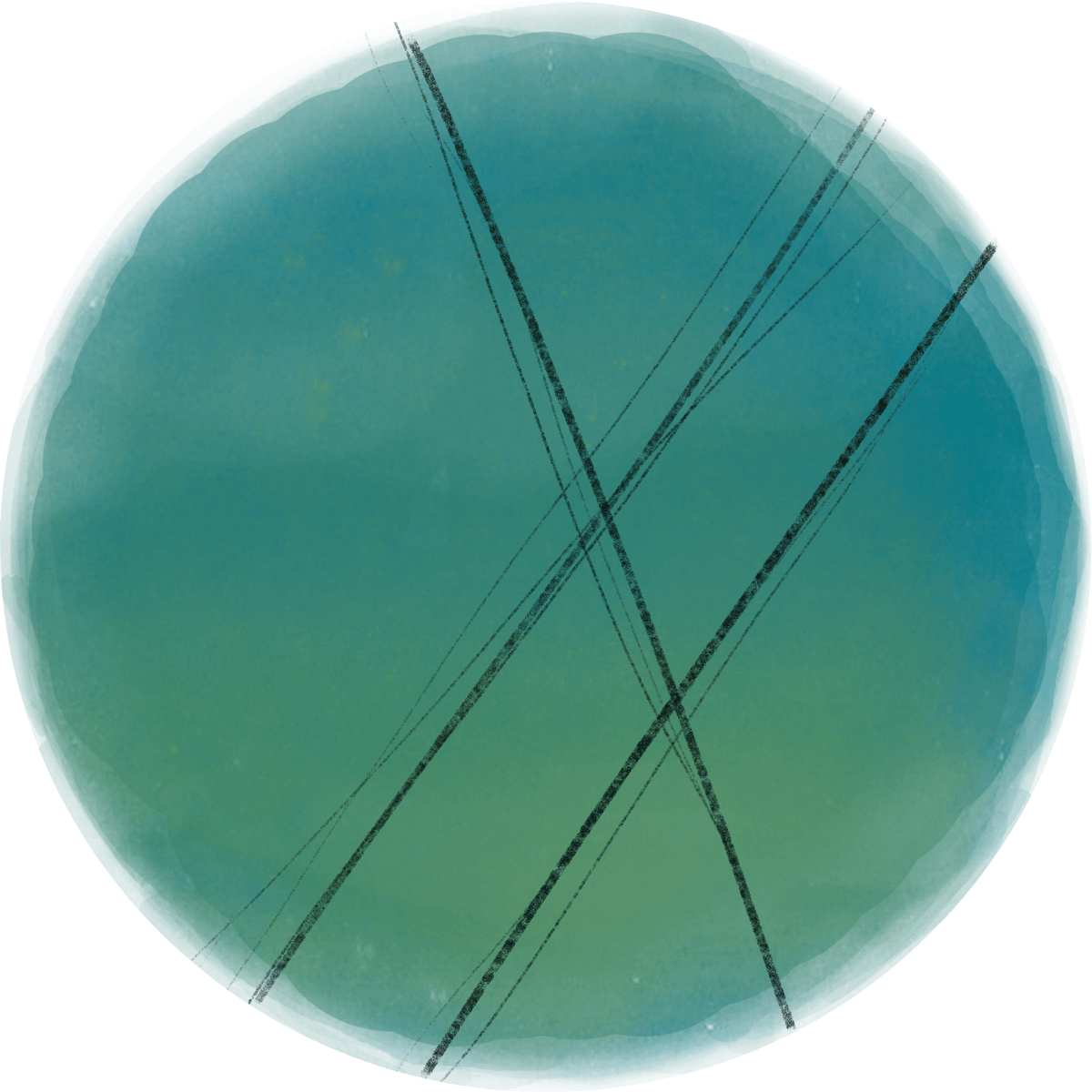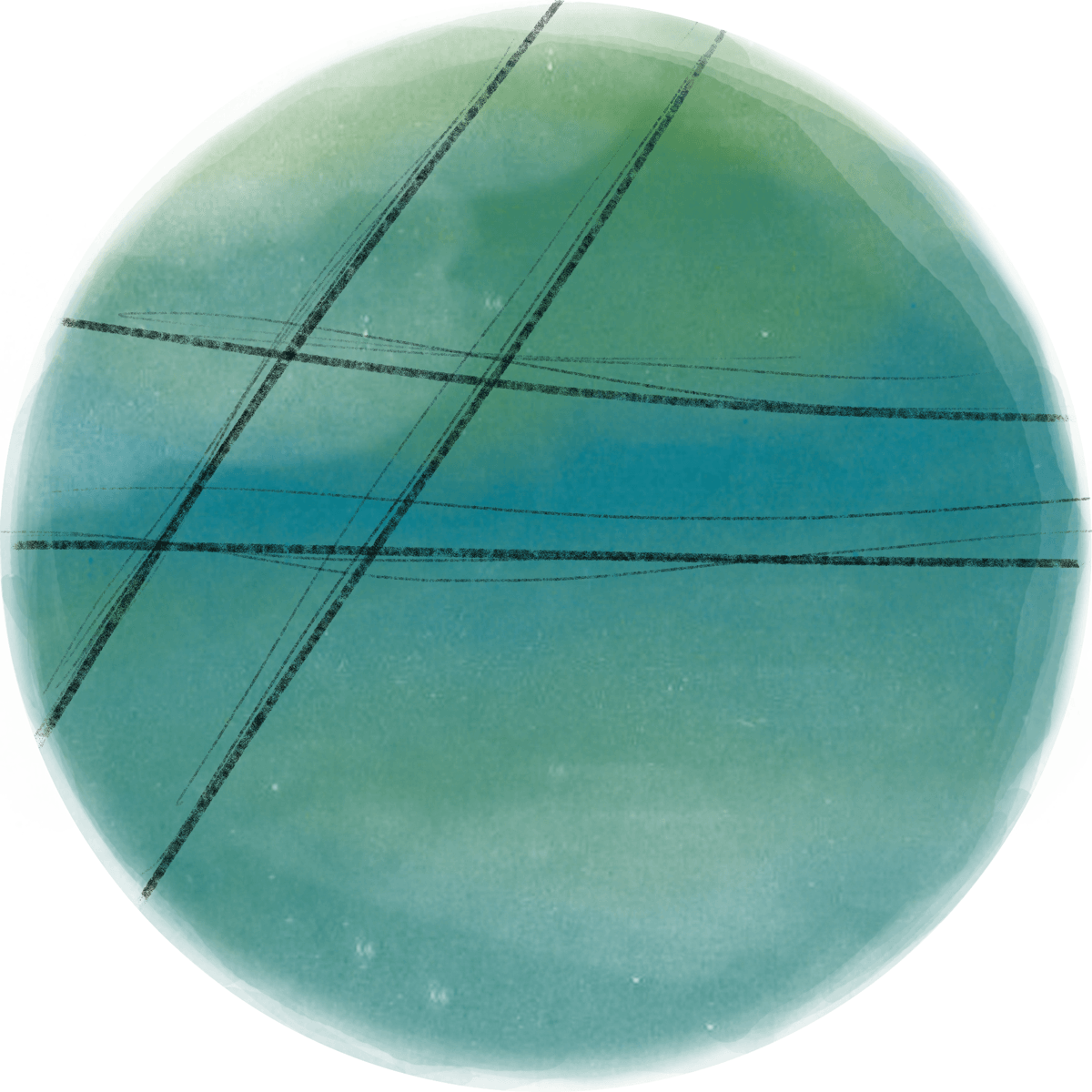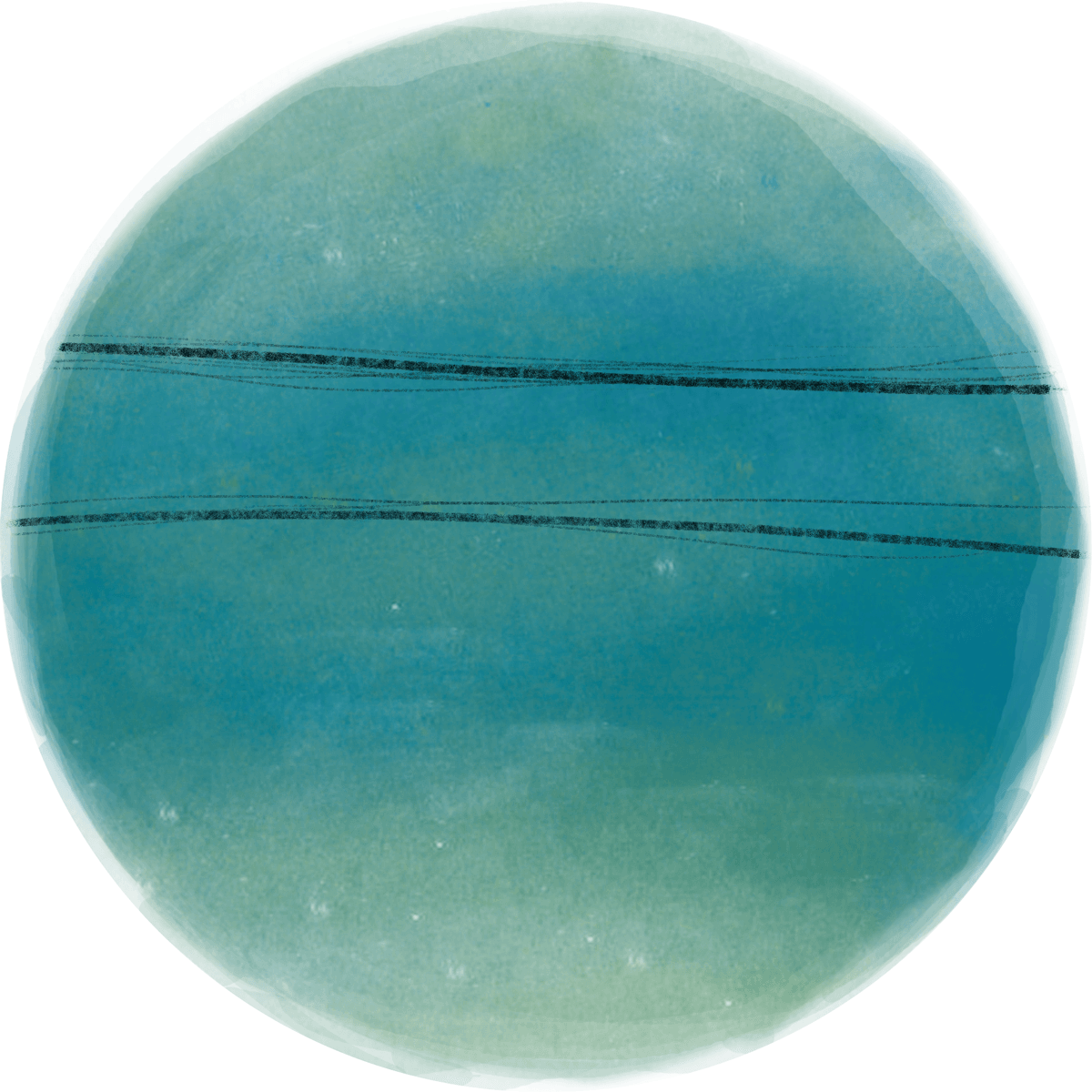9 Giugno 2020
Il trauma
Vivere eventi che creano una rottura

Si sente spesso parlare di trauma, tanto che questa parola è entrata a far parte del nostro linguaggio quotidiano per indicare quelle situazioni che ci mettono in difficoltà e ci fanno stare male: diciamo di subire un trauma quando veniamo coinvolti in un incidente, aggrediti o quando abbiamo una reazione di grande spavento o dolore.
Questa diffusione della parola ci dice che il trauma è un tema ampiamente riconosciuto, ma viene spesso usata in modo ampio, per cui può essere utile qualche riflessione su che cosa sia il trauma dal punto di vista psicologico, quali siano le dinamiche emotive che si attivano in questo tipo di situazioni e quali possano essere le strategie di gestione.
La parola “trauma” ha origini nel greco antico in cui il termine utilizzato indica una ferita, una lesione che lascia segni visibili nella persona. In italiano il termine si riferisce ad eventi che possono coinvolgere sia il corpo sia la psiche della persona. Si parla del trauma fisico per riferirsi a una “lesione prodotta nell’organismo da un qualsiasi agente capace di azione improvvisa, rapida e violenta” (Vocabolario Treccani), si tratta di un agente che nel colpire il corpo neutralizza le difese che il nostro organismo mette in campo. In modo analogo, il trauma psichico consiste in un “turbamento dello stato psichico prodotto da un avvenimento dotato di notevole carica emotiva” (Vocabolario Treccani), anche in questo caso l’avvenimento traumatico è in grado di debellare le difese psichiche di cui l’individuo dispone per tutelarsi. Chiaramente, questo può avere importanti conseguenze sullo stato mentale ed emotivo della persona.
Quando parliamo di trauma, è importante distinguere tra l’evento e la reazione traumatica, perché non tutti gli eventi suscitano nelle diverse persone le stesse reazioni.
L’evento traumatico è un accadimento straordinariamente grave, capace di sopraffare la persona, le sue capacità di tutela di sé e di adattamento, a livello fisico e psicologico. In psicotraumatologia si distinguono due tipi di eventi traumatici: il primo è chiamato Trauma con la T maiuscola, consiste nelle situazioni che minacciano l’incolumità e la sopravvivenza dell’individuo o di persone a lui vicine. Ne sono esempi una catastrofe naturale, un’aggressione, abusi e violenze fisiche e sessuali, un grave incidente, la diagnosi di una grave patologia.
Il secondo tipo di eventi è indicato con il termine trauma con la t minuscola ed indica quegli eventi particolarmente critici, difficili, angoscianti che, pur non minacciando la sopravvivenza della persona, possono presentarsi ripetutamente ed essere tanto significativi da suscitare una sofferenza profonda e duratura. Ne sono esempi un abbandono, la rottura di un legame sentimentale, le trascuratezze vissute nel rapporto con i genitori o con il partner.
Questa distinzione viene fatta in virtù della diversa natura degli eventi, non si riferisce alla reazione della persona travolta da essi: un abbandono, ad esempio, per alcune persone può avere conseguenze emotive sconvolgenti, tanto quanto l’essere coinvolti in un incidente mortale.
Volendo dare una definizione più formale del trauma psicologico, possiamo affermare che esso consiste nell’insieme di reazioni psichiche attivate automaticamente da una persona che deve fronteggiare un evento sconvolgente, spesso si tratta di una catastrofe naturale oppure di un’atrocità commessa da un’altra persona. Tali situazioni sconvolgono e annientano i sistemi di difesa di chi le vive, per cui la persona sente di non poter avere il controllo della situazione, si sente impotente, indifesa, non riesce a dare un significato coerente all’evento. Proprio i sentimenti di impotenza, di terrore, la percezione di non avere il controllo e la paura di essere annichiliti dalla situazione sono i vissuti tipici che contraddistinguono l’esperienza traumatica.
Le reazioni al trauma

Vivere eventi traumatici coinvolge l’esperienza della persona nella sua totalità: sia la mente sia il corpo ne sono travolti e tentano di reagirvi al meglio delle loro possibilità.
Fisiologicamente, alcune ricerche hanno evidenziato come la reazione traumatica comporti cambiamenti precisi nel funzionamento dell’encefalo: alcune zone cerebrali sono iperattivate (amigdala, giro del cingolo posteriore, corteccia motoria), altre vedono una riduzione dell’attivazione (corteccia prefrontale, parietale e temporale). L’attività dell’ippocampo è alterata e in generale le comunicazioni tra le diverse strutture dell’encefalo sono rese più difficili.
Tali alterazioni dell’attività cerebrale sono connesse a cambiamenti nell’esperienza soggettiva della persona: dal momento che le connessioni tra le diverse strutture cerebrali sono ostacolate dalla reazione traumatica in corso, l’individuo può vedere alterata la sua capacità di memorizzare ciò che è accaduto.
Può accadere, infatti, che le informazioni sugli eventi accaduti e sulle emozioni vissute vengano memorizzate in aree cerebrali diverse e non collegate tra loro. Le informazioni sull’evento traumatico possono essere conservate in un registro primitivo al di fuori della consapevolezza (memoria simbolico-linguistica), per cui per l’individuo l’emozione stessa può diventare la memoria dell’evento traumatico. L’operazione parallela del sistema di memoria esplicita (ippocampo) ed implicita (amigdala) spiega perché spesso chi vive un evento traumatico non riesce a narrarlo e va incontro a fenomeni di amnesia e di somatizzazione.
Inoltre, di fronte a un evento traumatico si attiva automaticamente il sistema motivazionale di difesa, che coinvolge l’attività di strutture cerebrali localizzate nel tronco encefalico. Si tratta di un sistema antico a livello evolutivo, che esiste negli uomini così come negli animali e in tutte le specie si manifesta in modo simile. Il sistema motivazionale di difesa attiva una reazione d’allarme, molto simile a quella che avviene nelle situazioni di stress: la differenza consiste principalmente nell’intensità delle reazioni, nel caso di un trauma decisamente maggiore, e nella varietà delle risposte.
Sono 4 le risposte automaticamente attivabili dal sistema di difesa:
- Fight/attacco: è il tentativo di lottare contro la minaccia, per neutralizzarla e ritornare ad una situazione di calma.
- Fligh/ fuga: nel caso in cui non sia possibile o sia troppo rischioso ingaggiare una lotta, la scelta può ricadere sulla strategia di fuga, cioè scappare dal pericolo nel tentativo di preservare la propria integrità.
- Freezing/congelamento: nel caso in cui le precedenti strategie non siano attuabili, la persona può ricorrere (in modo automatico e non consapevole) ad una strategia molto primitiva, cioè trovarsi in uno stato di immobilità ipertonica con conservata padronanza sulla motilità (congelamento o ipervigilanza). Di fatto la persona è vigile, sente ciò che accade, ma lo stato di allarme e terrore è talmente alto da paralizzarla, impedendole di muoversi e di fare qualsiasi cosa.
- Faint: l’ultima strategia, messa in atto del tutto involontariamente in circostanze estreme, consiste in uno stato di immobilità ipotonica o cataplettica, con perdita della padronanza sulla motilità (svenimento o distacco).
L’attivazione del sistema di difesa svolge funzioni preziose per la persona: ne preserva la sopravvivenza. Tuttavia, quando è attivo, ostacola l’attività cognitiva (troppo lenta e dispendiosa nelle situazioni di urgenza), in particolar modo colpendo le abilità connesse all’intersoggettività (propensione a condividere l’esperienza) ed alla metacognizione (comprendere la realtà, riflettere sui contenuti mentali propri e altrui), per cui capita che nelle situazioni traumatiche l’individuo riesca meno ad essere riflessivo e propenso alla collaborazione e condivisione.
La dissociazione: una difesa frequente

Il trauma non è inevitabilmente legato al successivo sviluppo di un disturbo psicologico, tuttavia suscita l’attivazione di dinamiche mentali di tipo dissociativo.
Concetto centrale della dissociazione è la separazione e la non integrazione di contenuti mentali in condizioni di stress severo, con conseguente interruzione dei collegamenti fra processi psicologici, cioè tra pensiero, emozioni e memoria.
La dissociazione può essere normale o patologica. Nel primo caso si tratta di un processo psicologico di reazione allo stress non traumatico: è una difesa che protegge l’individuo nelle situazioni difficili, cioè un vero e proprio organizzatore psicologico; ci possiamo accorgere della sua presenza tutte le volte che la nostra mente, infastidita da ciò che sta succedendo, se ne va altrove: ad esempio, “ciò che accade e sento mi urta, mi distraggo, penso ad altro”.
La dissociazione patologica si osserva quando tale difesa è attivata in modo massiccio, tanto da diventare disfunzionale ed accentuare la sofferenza dell’individuo anziché aiutarlo ad affrontare l’evento. In questo caso, dentro la persona si crea una “frattura”, una separazione: i vissuti emotivi dolorosi connessi al trauma rimangono dissociati, incapsulati e dislocati in una parte di lei non sempre consapevole, mentre un’altra parte della persona si mostra più razionale e in grado di portare avanti la propria vita normale, coinvolgendosi nelle attività quotidiane con modalità di funzionamento adeguate. Nella dissociazione patologica, la parte emotiva rimane fissata sul trauma in uno stato di continua ri-esperienza dell’evento traumatico come attuale: è come se la persona rivivesse in ogni istante o in ogni circostanza la stessa situazione traumatica e questo può portare, ad esempio, a percepire uno stato continuo di nervosismo, di allarme o di angoscia. Un’altra caratteristica tipica della dissociazione patologica consiste nel fatto che, in situazioni che attivano la sua parte emotiva, l’individuo può trovarsi ad agire in modo impulsivo, a volte in uno stato alterato di coscienza; inoltre, è frequente sperimentare dimenticanze importanti: può succedere che la persona non ricordi che cosa ha fatto lungo un’intera giornata o durante un appuntamento importante o in un incontro in cui si è sentita particolarmente attivata o sconvolta.
Come si sente una persona che vive una situazione di dissociazione? Per darne alcuni esempi, trascriviamo alcune vignette tratte dal libro di Steinberg e Schnall (2006), che citano testimonianze di persone che vivono stati più o meno gravi di dissociazione.
“Quando sono assorta nella lettura di un bel libro, perdo la cognizione del tempo” (Alice M., 33 anni, tutor operator).
“Sento come se il mio corpo non facesse quello che vuole la mia testa” (Ernest P., 51 anni, ingegnere).
“La mia mente vaga e io entro ed esco. Mi estranio da me stessa. In realtà sono sempre lì, solo che non sono presente” (Sandra N., 19 anni, studentessa).
“Dopo che ho finito, ho problemi a ricordare quello che ho detto durante una presentazione” (John T., 41 anni, direttore del settore vendite di un’azienda di commercio elettronico).
“Ero a casa con mia madre e il tutto era irreale. Sapevo che quella era mia madre, ma avevo la sensazione che non fosse realmente lei” (Cindy M., 32 anni, produttrice televisiva).
“Esplodo con mio marito, dopo di che non riesco a ricordare che cosa ho detto” (Gayle T., 32 anni, istruttrice d’aerobica).
“Mi sembra irreale oppure mi sembra di fare le cose in maniera automatica” (Jim Z., 37 anni, counsellor per alcolisti).
“Mi sento una ragazza per la maggior parte del tempo; altre volte mi sento più come se fossi un ragazzo” (Carly B., 19 anni, studentessa).
“È come guardare un film che si svolge nella testa. Sai, come quando sei assorto nella visione e dimentichi chi sei, che ore sono, quello che sta succedendo nella tua vita” (Donna E., 41 anni, infermiera).
“Mi accade di essere così interessato a ciò che le persone pensano di me o si aspettano da me che quando parlo con loro mi perdo – perdo me stesso” (George N., 53 anni, financial planner).
“Non riuscivo a ricordare se fosse successo veramente o l’avessi solo immaginato” (Suzanne O., 35 anni, casalinga).
“È come essere sotto shock – sai che stai facendo una cosa, ma ti sembra che sia qualcun altro a farla. Ti guardi da lontano. Non lo provano tutti a volte?” (Robert A., 51 anni, amministratore scolastico).
“Non mi sento me stesso; mi sento come un’altra persona al mio interno” (Vicki B., 44 anni, tecnico di attrezzature mediche).
“Quando ho divorziato non ho permesso a me stesso di provare nulla fino a quando non è finito tutto. la parte emotiva di me si disattiva sotto stress” (Fred D., 42 anni, analista finanziario).
“Sono in un guscio e mi sento vuota dentro” (Linda A., 33 anni, insegnante).
“Una potentissima onda emotiva mi travolge e non ho più il controllo di me stessa. Sento che questa persona sta per fare quello che vuole e io sono al di sopra, in un angolo, inerme, ad aspettare di vedere quello che succede” (Penelope J., 54 anni, scrittrice free-lance).
Come mai si sviluppano delle difese di questo tipo? Il principale predittore di uno sviluppo dissociativo non è tanto l’essere esposti ad un trauma in sé, ma piuttosto vivere esperienze di attaccamento disorganizzato nei primi periodi della propria vita (prima e seconda infanzia).
Il sistema di attaccamento si attiva quando si verifica un evento che minaccia la sicurezza dell’individuo (paura, dolore, sonno) e lo predispone a richiedere l’aiuto di una persona fidata. Le strategie utilizzate per chiedere aiuto vengono apprese nella relazione con i genitori, in base alle risposte di accudimento ricevute. La relazione con i genitori funziona come modello per le successive: dà origine ad uno schema mentale che orienta il proprio comportamento, ma anche le aspettative rispetto alla condotta altrui.
In che senso le esperienze di attaccamento possono predire il funzionamento dissociato? Se il bambino vive esperienze traumatiche nella relazione con i propri genitori, può sperimentare che chi dovrebbe prendersi cura di lui è pericoloso. Questo è un conflitto intollerabile per un bimbo: lo espone al rischio di mettere in atto difese dissociative massicce e di strutturare su questo funzionamento la propria personalità ed il proprio modo di stare in relazione.
I disturbi da trauma secondo il DSM-5
Il DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, classifica in un’apposita sezione i disturbi psicologici connessi ad eventi traumatici. Tra le patologie descritte, due sono quelle che si osservano più frequentemente.
Il DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO (PTSD) è una patologia che può insorgere quando il soggetto vive in prima persona un evento traumatico o assiste ad un trauma che coinvolge altre persone.
I sintomi tipici del PTSD sono:
- Intrusioni: flashback spiacevoli, incubi, pensieri involontari, avere di fronte l’immagine dell’evento traumatico. Tutto ciò provoca angoscia perché si rivive l’episodio senza la capacità di pensarsi altrove.
- Evitamento: tentativi di evitare i ricordi o i pensieri dolorosi connessi al trauma e le persone o cose che possono suscitare il ricordo e le emozioni ad esso connesse.
- Alterazioni del pensiero o delle emozioni: amnesie, convinzioni e aspettative negative rispetto a sé e al mondo, senso in colpa per l’accaduto, distacco e perdita d’interesse per le attività quotidiane e per le persone, incapacità di provare emozioni positive.
- Aumentato arousal: reazioni vegetative, disturbo del sonno, mancanza di concentrazione, irritabilità.
- Numbing o ipoarousal: nebbia emotiva, anestesia confusa, sorta di istupidimento.
Il PTSD insorge dopo l’evento traumatico, suscita una sofferenza clinicamente significativa ed altera il funzionamento personale, sociale e lavorativo. Se non trattato con una psicoterapia ed eventualmente con una terapia farmacologica, il disturbo perdura fino a cronicizzarsi e può associarsi ad altri disturbi mentali (disturbo depressivo, bipolare, d’ansia, disturbo da uso di sostanze).
I DISTURBI DELL’ADATTAMENTO sono un insieme di reazioni psicopatologiche ad un evento stressante: suscitano un disagio marcato nell’individuo, alterandone il funzionamento personale, sociale e lavorativo. I sintomi sono molto diversi da quelli del PTSD, insorgono a breve distanza dall’evento stressante e si risolvono entro sei mesi dalla fine dell’evento stesso. Ad esempio, nel caso della diagnosi di una malattia, il disturbo può manifestarsi poco dopo la diagnosi, ma i sintomi dovrebbero risolversi entro sei mesi dopo la guarigione.
Il DSM-5 individua 5 tipi di disturbi dell’adattamento (oltre al disturbo dell’adattamento non specificato), in base alla sintomatologia presentata dall’individuo:
- Con umore depresso: persistente umore basso, facilità al pianto e alla disperazione.
- Con ansia: persistente nervosismo, inquietudine, agitazione, ansia di separazione.
- Con ansia e umore depresso misti: si osserva una combinazione di sintomi ansiosi e depressivi.
- Con alterazioni della condotta: sono prevalenti condotte anomale e disfunzionali per quella persona in relazione al suo contesto socio-culturale.
- Con alterazione mista dell’emotività e della condotta: si osserva una combinazione di sintomi ansioso-depressivi e condotte alterate.
I disturbi dell’adattamento sono spesso presenti in caso di ospedalizzazione o quando la presenza di una malattia cronica impone di seguire un percorso terapeutico molto invasivo che provoca un drastico cambiamento dello stile di vita e delle abitudini dell’individuo.
Quali prospettive terapeutiche?

Nei casi in cui la sofferenza della persona è connessa ad esperienze e a vissuti di tipo traumatico, è molto utile prendersene cura ricorrendo all’aiuto di uno specialista. In particolare, sono importanti i percorsi di psicoterapia, sia individuale sia di famiglia, e quelli di tipo psichiatrico, che garantiscono un supporto farmacologico mirato a contenere ed attenuare la sintomatologia.
Per quanto riguarda la psicoterapia, possono essere molto utili due approcci complementari, entrambi tesi a risolvere la sofferenza che nasce dall’esperienza traumatica. Il primo consiste nella psicoterapia individuale avvalendosi della tecnica EMDR (tecnica di desensibilizzazione basata sul movimento oculare bilaterale), il secondo nella psicoterapia di famiglia. Mediante questi approcci è possibile raggiungere di versi obiettivi volti a migliorare lo stato di salute psichica e la qualità di vita delle persone che hanno subito traumi:
- Attenuare il livello di sofferenza e di allarme che caratterizza l’esperienza traumatica.
- Integrare nella propria memoria e nella propria narrazione le varie parti di ricordo traumatico che rimangono frammentate a causa delle particolari alterazioni fisiologiche sopra descritte: questo permette alla persona di creare una narrazione coerente di quanto accaduto, di attribuire un significato ed un senso agli eventi che l’hanno coinvolta.
- Migliorare la propria capacità di vivere e gestire le emozioni (intaccata dal trauma), sia quelle dolorose ma anche quelle piacevoli.
- Elaborare strategie efficaci per tutelarsi e prendersi cura di sé nelle varie situazioni che possono essere critiche o minacciose.
- Risanare la possibilità di nutrire fiducia in se stessi e nel prossimo, anche questa assai spesso intaccata dal trauma.
- Migliorare la qualità delle relazioni familiari e sociali, che vengono alterate dal trauma, contrastando quel senso di isolamento estremamente doloroso che spesso chi ha subito un trauma vive .
Vari interventi complementari e paralleli alla psicoterapia ed alla terapia psichiatrica, come ad esempio la mindfulness, la pet therapy, la musicoterapia e l’arteterapia, possono aiutare la persona a prendersi cura del proprio malessere emotivo e ad alimentare la propria capacità di creare e coltivare relazioni interpersonali soddisfacenti e supportive.
Bibliografia
- American Psychiatric Association (2014), DSM-5 Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali Quinta Edizione, Milano, Raffaello Cortina
- Fisher J. (2017), Guarire la frammentazione del sé. Come integrare le parti del sé dissociate dal trauma psicologico, Milano, Raffaello Cortina
- Giove M., Bardelli D., Brolato G., Destefanis C., La Marra E., Panebianco A., Rolle S. (2016), Psicologia delle Relazioni Interpersonali, Dispensa per gli studenti del Corso di Laurea di Infermieristica – Canale TO4 Ivrea, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino
- Herman J.L. (2005), Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, dall’abuso domestico al terrorismo, Roma, Edizioni Magi
- Liotti G., Farina B. (2011), Sviluppi traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della dimensione dissociativa, Milano, Raffaello Cortina
- Steinberg M., Schnall M. (2006), La dissociazione. I cinque sintomi fondamentali, Milano, Raffaello Cortina
- Van Der Kolk B. (2015), Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazione delle esperienze traumatiche, Milano, Raffaello Cortina
- Vocabolario Treccani
Contatti
Chiama
Scrivi
Mi trovi in