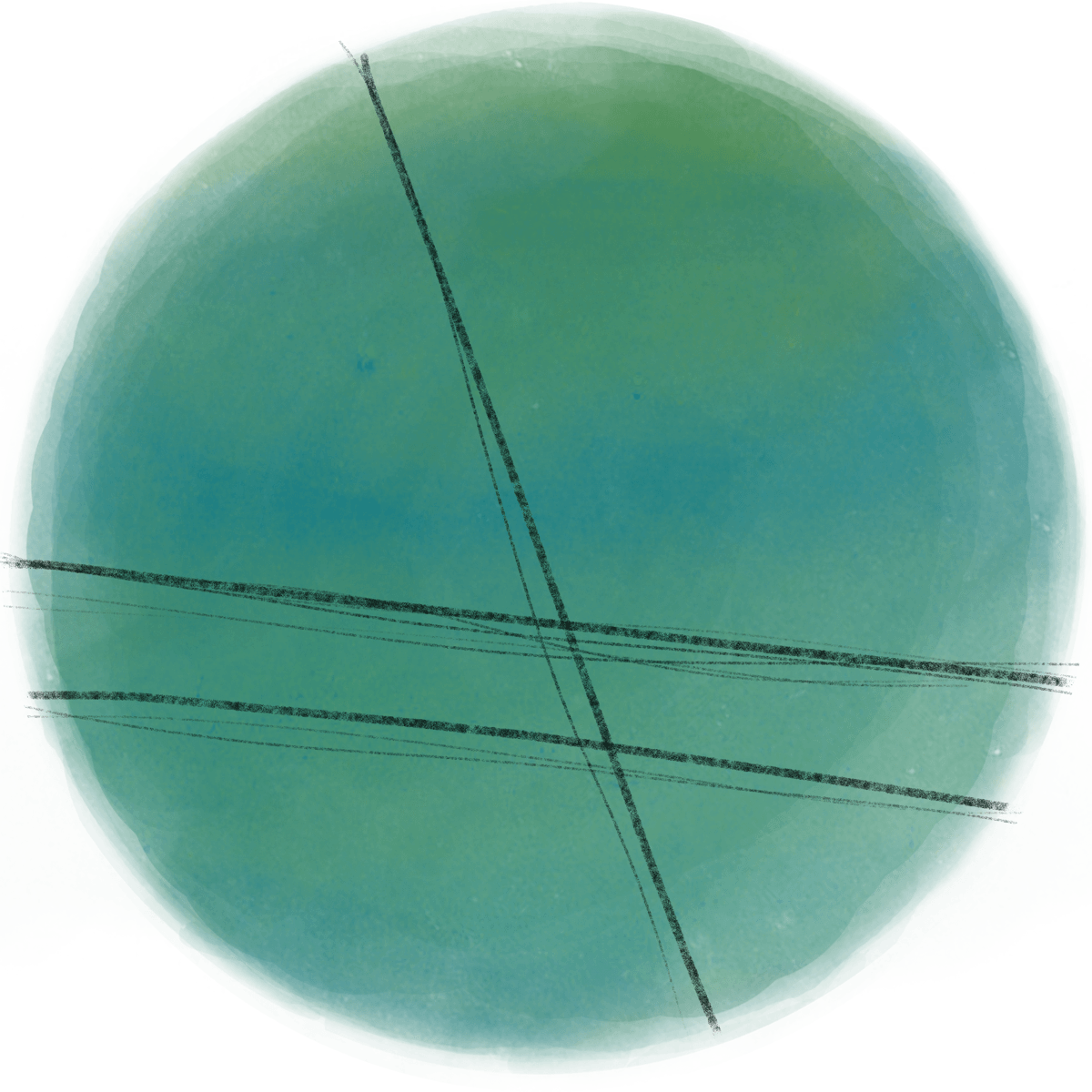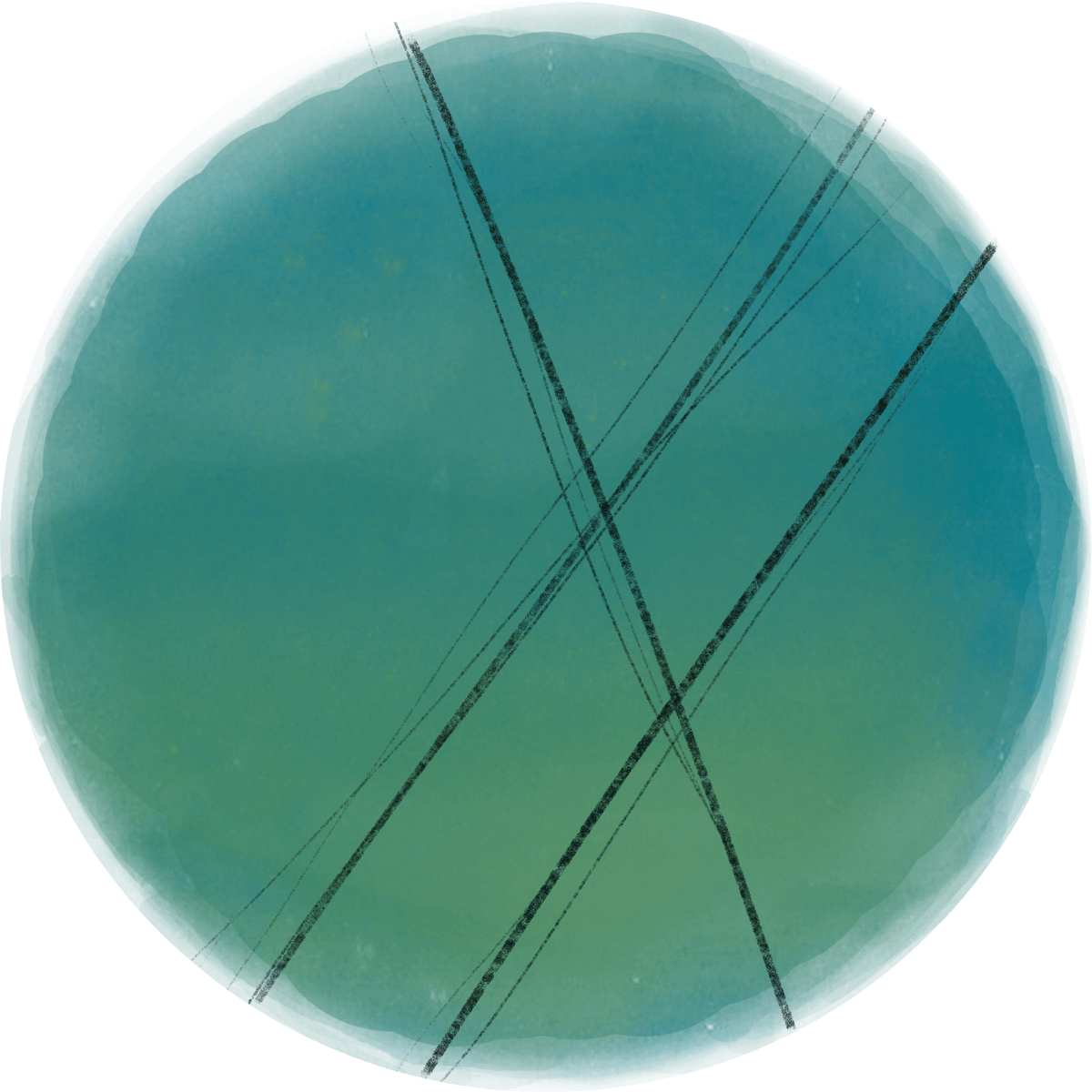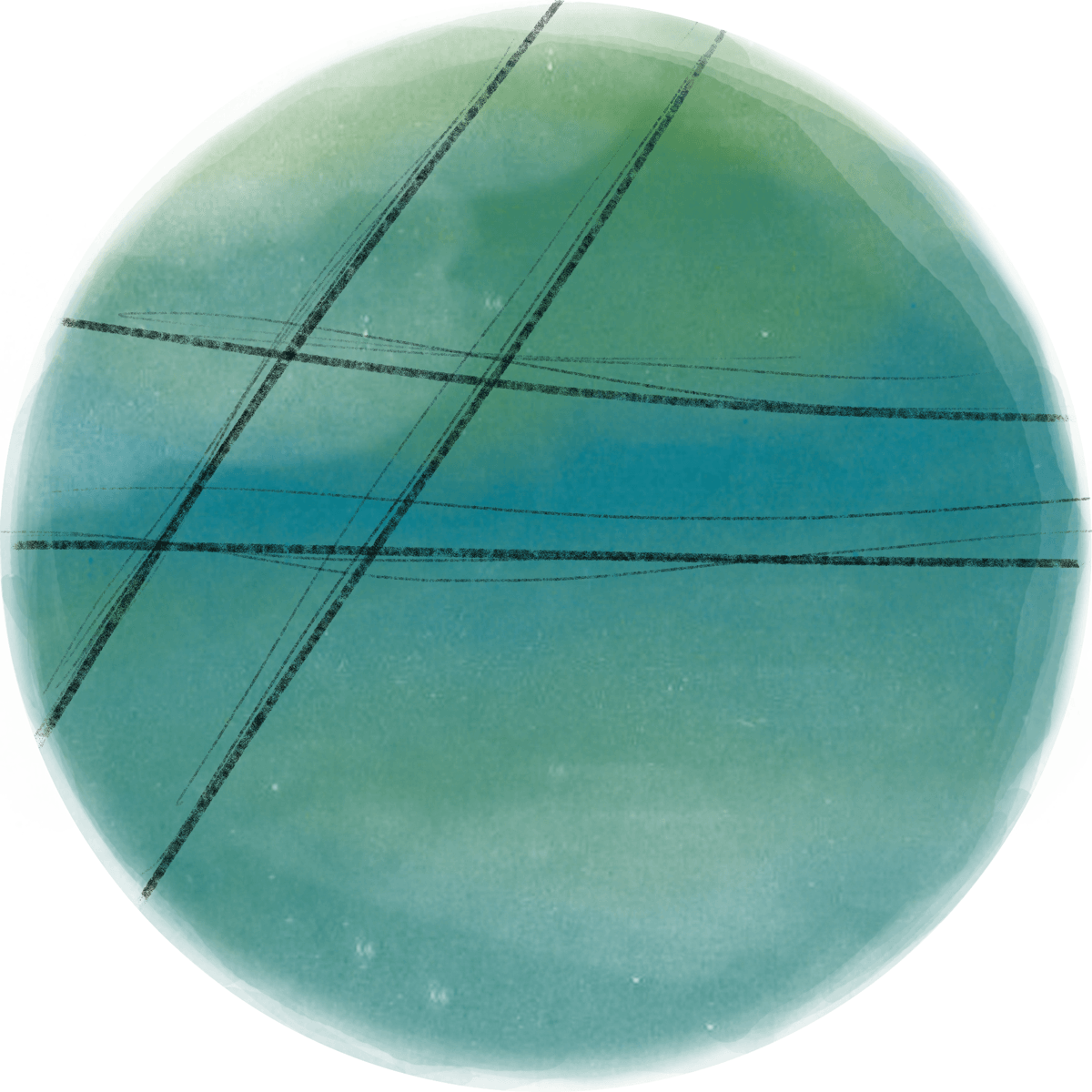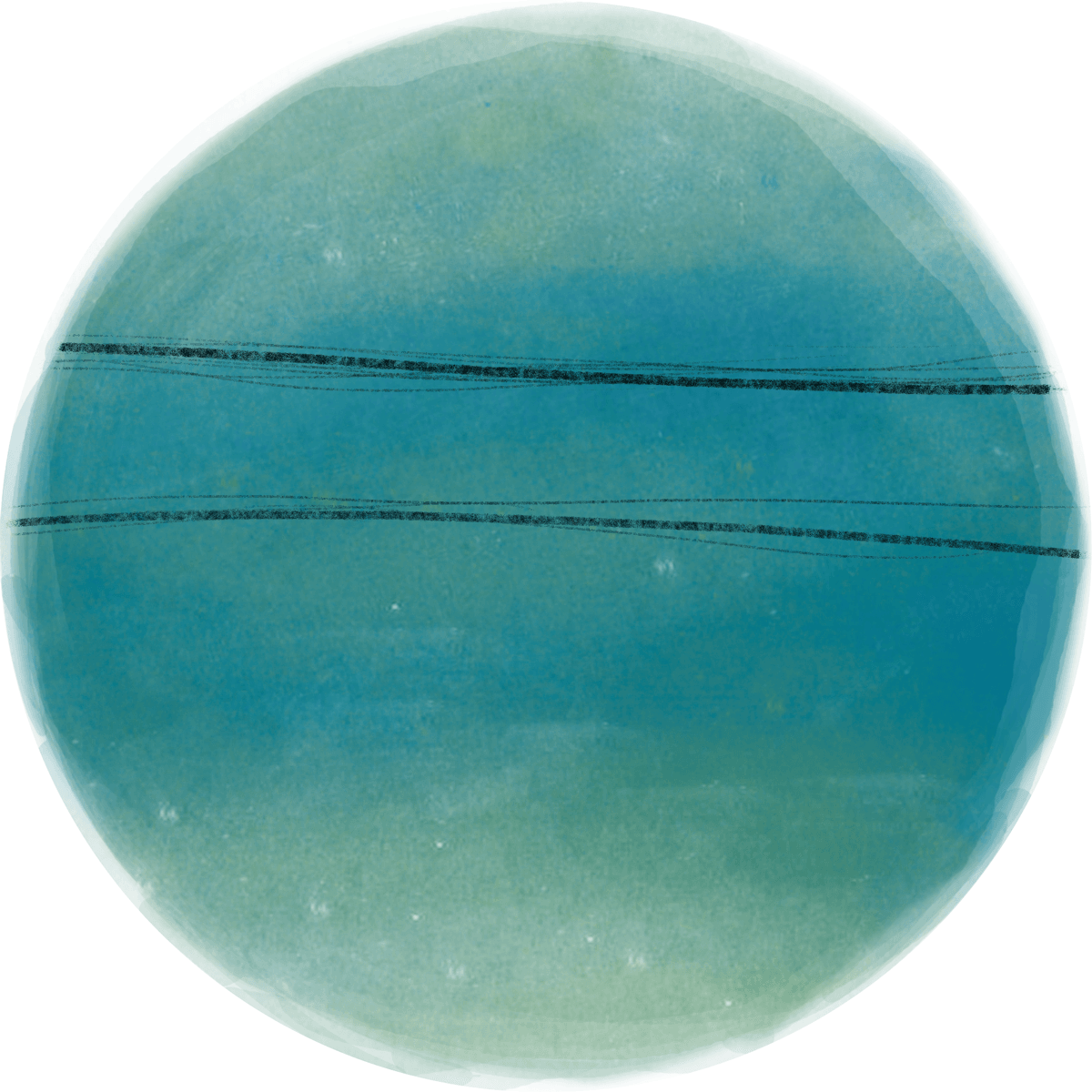23 Marzo 2020
Quanta ansia!
Di che cosa si tratta? Come gestirla e riconoscerla?
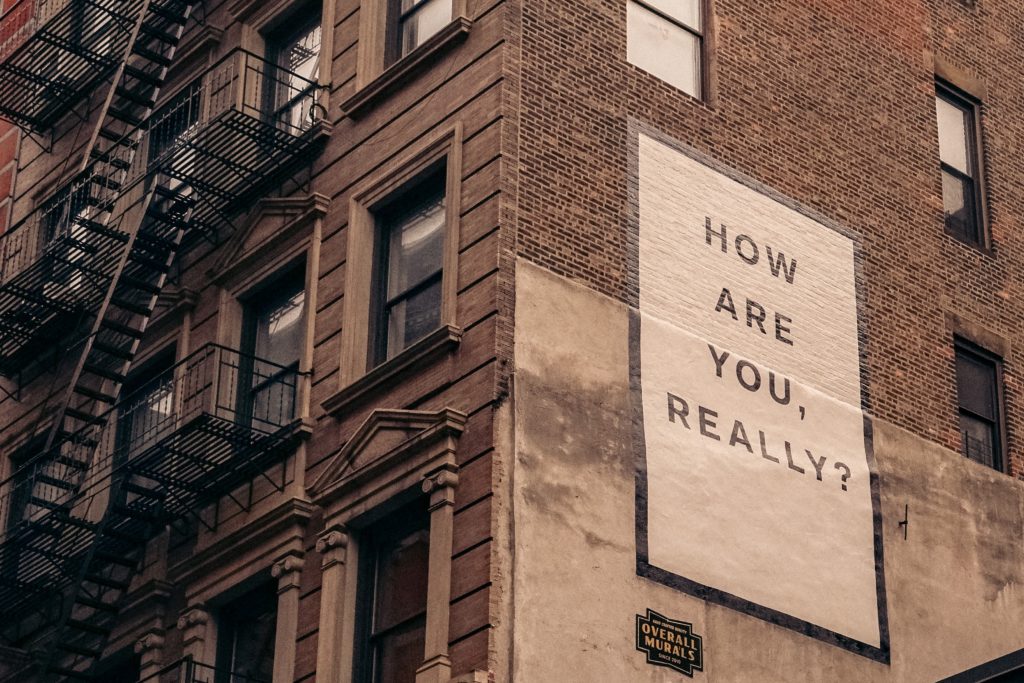
Emozioni, un ponte tra mente e corpo
Per introdurre che cosa sia l’ansia e come gestirla nella nostra vita quotidiana, può essere utile fare una breve premessa sulle emozioni, che cosa sono e a cosa servono… perché l’ansia è una forma particolare di emozione!
Le principali teorie psicologiche considerano le emozioni come risposte del nostro organismo di fronte ad uno stimolo ambientale (un rumore improvviso, un dono inatteso, una melodia particolare…) oppure interno (un ricordo, una fantasia, una sensazione…). Si tratta di risposte che nascono sia nella nostra mente sia nel nostro corpo, pensiamo a come ci batte forte il cuore e a come cambia il nostro respiro quando siamo spaventati, ed hanno l’obiettivo di permettere alla persona di trovare un adattamento rispetto alle circostanze ambientali e di vita. Proprio per questo, le emozioni sono fenomeni complessi, costituite da diverse componenti: vi è l’esperienza soggettiva dell’emozione, cioè come ci sentiamo quando diciamo che abbiamo paura oppure che siamo felici, ma vi è anche una modificazione fisiologica che comporta ad esempio il cambiamento del funzionamento dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e muscolare, che ha lo scopo di preparare il nostro corpo a reagire allo stimolo; le emozioni comportano anche un cambiamento cognitivo, pensiamo ad esempio a come cambia il nostro pensiero quando siamo arrabbiati rispetto a quando ci sentiamo felici, e, molto importante, attivano anche determinate espressioni, facciali prima di tutto, che ci permettono di comunicare all’altro come ci sentiamo in un dato momento.
Per comprendere il modo in cui le emozioni, tra cui l’ansia, si manifestano nella persona e quindi per imparare a gestirle, è molto utile comprendere alcune caratteristiche del funzionamento umano. In particolare, quando succede qualcosa che suscita un’emozione, quest’ultima nasce grazie all’attivazione di alcune aree del nostro encefalo che a loro volta generano altri cambiamenti nel nostro organismo. Per il modo in cui si attivano questi centri del nostro cervello, succede che le emozioni “nascano” in primo luogo nel nostro corpo, cioè i cambiamenti fisiologici (alterazioni del respiro, del battito cardiaco, della tensione muscolare e simili) avvengono prima e più velocemente della presa di coscienza dell’emozione; solo in un momento successivo la persona prenderà consapevolezza dell’emozione che sta provando, dei pensieri che nascono da quello stato emotivo e dell’intenzione di agire in un determinato modo. Questo avviene perché le aree cerebrali coinvolte nella consapevolezza funzionano più lentamente rispetto a quelle che attivano i cambiamenti fisiologici. Questo comporta che, in situazioni di emergenza, le emozioni ci permetteranno di agire rapidamente ed in modo istintivo, fattori cruciali quando bisogna rispondere con urgenza ad un pericolo. Ma comporta anche che, in generale, in determinate situazioni possono nascere in noi delle emozioni anche senza che lo vogliamo, perché esse nascono al di fuori della nostra consapevolezza… non serve quindi sentirci in difetto se proviamo emozioni che non vorremmo o che non ci sembrano adeguate. Quando diventiamo consapevoli di un’emozione, può essere utile cercare di ascoltarla e comprenderla, comprendere cosa l’ha suscitata, come ci fa stare e cosa attiva in noi; questo permette di rendere più tollerabile l’emozione e di imparare a gestirla di modo che possa essere un aiuto anziché un ostacolo.
Che cos’è la paura?
Può essere utile soffermarci sull’emozione di paura, perché quando proviamo ansia facciamo un’esperienza molto simile, anche se tra le due emozioni ci sono alcune importanti differenze che sottolineeremo.
La paura è una risposta emotiva ad una minaccia imminente, reale o percepita. Quando proviamo paura, il pericolo è presente nell’immediato, tangibile. Proprio per questo, quando la paura insorge, si attiva il nostro sistema nervoso autonomo simpatico, che attiva il nostro corpo con tutta una serie di cambiamenti che lo preparano all’azione, quindi all’attacco o alla fuga dalla minaccia.
Quali sono i cambiamenti che la paura genera nel nostro organismo e che ci fanno capire che siamo spaventati? Le pupille si dilatano, il battito cardiaco accelera, la pressione arteriosa aumenta, la salivazione e la digestione si interrompono, la respirazione si fa più veloce e profonda, aumenta la traspirazione cutanea e la sudorazione può farsi profusa contribuendo a raffreddare il corpo, aumentano i livelli di glicemia e la rapidità dei processi coagulativi. Si tratta, come possiamo intuire, di cambiamenti che preparano l’organismo ad agire in modo rapido per rispondere al pericolo imminente.
La risposta di paura può assumere principalmente quattro forme:
- Pianto d’attaccamento, cioè una richiesta d’aiuto a una persona fidata o disponibile;
- Attacco, spinge ad ingaggiare una lotta con o affrontare chi o che cosa costituisce una minaccia;
- Fuga, permette di allontanarsi dal pericolo, evitando di affrontarlo;
- Freezing, cioè una reazione automatica di congelamento che impedisce alla persona di reagire.
Che cos’è l’ansia?

L’ansia somiglia alla paura nel farci sentire spaventati rispetto ad un pericolo ma, a differenza della paura, nell’ansia la minaccia è qualcosa di futuro, non immediatamente presente, ma anticipato. Se si teme qualcosa per il proprio futuro, l’ansia può suscitare in noi tensione muscolare, può renderci più vigili rispetto al futuro e farci adottare comportamenti prudenti o evitare alcune circostanze.
Come tutte le emozioni, anche l’ansia coinvolge sia la nostra mente sia il nostro corpo, è un’emozione che nasce in primo luogo nel corpo e poi coinvolge anche la nostra consapevolezza. Possiamo quindi capire che siamo in ansia ascoltando i cambiamenti che nascono in noi sia a livello fisico sia a livello mentale. Proprio per questo può essere utile elencare tali cambiamenti, così da poterli riconoscere con più facilità.
Di seguito descriviamo i principali sintomi fisici dell’ansia:
- Dolori muscolari
- Contratture muscolari o intorpidimenti
- Contrazione mandibolare/bruxismo
- Disturbi del ritmo cardiaco
- Disturbi del respiro
- Alterazioni della digestione: dispepsie/nausea/conati di vomito
- Disfagia
- Eccesso di psicotropi
- Dismenorrea
- Frigidità o disturbi della sessualità
- Disturbi della diuresi
- Cefalea
- Riduzione della salivazione
- Rossore o pallore
- Parestesie o alterazioni della sensibilità
- Ronzio auricolare/acufeni
Elenchiamo ora i principali sintomi psichici dell’ansia:
- Incapacità a rilassarsi
- Preoccupazione
- Paura per il futuro
- Trasalimenti
- Tremiti
- Maggiore timore per eventi stressanti
- Irritabilità
- Alterazioni dell’appetito, cioè iporessia o bulimia
- Rituali alimentari
- Ritorno mentale sull’evento
- Riduzione della memoria
- Difficoltà di concentrazione
- Disturbi dell’addormentamento o del risveglio
- Riposo incompleto o agitato
- Stanchezza da risveglio
- Incubi
Una questione spesso dibattuta è se l’ansia sia un fenomeno normale oppure una manifestazione patologica. In generale, possiamo dire che l’evoluzione ci ha dotati, con l’ansia, di un’attivazione emotiva utile a proteggere la persona e la specie dai pericoli del mondo esterno. Si tratta di un meccanismo di allerta che in diverse situazioni può rivelarsi utile a scopo di difesa rispetto ad una minaccia futura: quando si sente in ansia la persona si prepara ad attuare strategie di attacco o fuga simili a quelle attivate dalla paura.
Ci sono, tuttavia, situazioni in cui l’ansia può diventare poco utile o addirittura un problema. Si tratta dei casi in cui la persona si sente in ansia perché spaventata da eventi che normalmente non suscitano paura. Oppure delle situazioni in cui l’individuo considera la propria ansia eccessiva, indesiderata e troppo problematica, tanto da alterare la propria qualità di vita. Oppure ancora, dei casi in cui la persona teme un pericolo ipotetico e lontano così tanto da sentirsi costretta a rimuginare continuamente su tutti gli eventi spiacevoli che possono ipoteticamente capitare. Nel caso dell’ansia patologica, il continuo lavorio mentale e l’intensa attivazione emotiva non sono utili perché non riducono le possibilità che gli eventi negativi si verifichino (perché gli eventi futuri sono difficilmente controllabili) e perché comportano un notevole e inopportuno dispendio di energie portando la persona a sentirsi debole ed affaticata.
L’ansia secondo il DSM-5
Anche il DSM-5, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, propone la distinzione tra l’ansia normale e quella patologica.
Situazioni stressanti possono suscitare ansia e paura, in questo caso risposte funzionali di allerta che predispongono il nostro corpo ad agire e far fronte ad una situazione pericolosa. Il DSM-5 descrive i disturbi d’ansia come situazioni in cui l’ansia anzichè essere un aiuto diventa un problema ed una fonte significativa di sofferenza. In particolare, secondo il DSM-5, i disturbi d’ansia si differenziano dalla normale paura o ansia evolutive perché sono eccessivi e persistenti rispetto allo stadio di sviluppo; differiscono dalla paura o ansia transitorie e indotte da eventi stressanti perché sono persistenti, generalmente i sintomi durano almeno 6 mesi; si manifestano con paura o ansia eccessive e sproporzionate rispetto alla situazione contestuale e alla cultura di appartenenza.
Il DSM-5 indica anche quelli che possono essere fattori di rischio per lo sviluppo di un’ansia patologica: l’essere esposti a ripetuti eventi stressanti, sperimentare difficoltà nelle relazioni familiari o sociali, sperimentare relazioni di attaccamento non sicure, vivere in un contesto sociale e lavorativo non stabile o difficile.
Quali sono i principali disturbi d’ansia secondo il DSM-5? Ne descriviamo di seguito i principali tipi e le loro caratteristiche.
Disturbo d’ansia da separazione
- La persona è spaventata o ansiosa rispetto alla separazione dalle figure di attaccamento, ossia coloro che costituiscono un punto di riferimento importante e si prendono cura di lei, più tipicamente i genitori; lo spavento e l’ansia si manifestano con un livello di gravità inappropriato rispetto allo stadio di sviluppo.
- Si manifesta con paura o ansia persistenti per gli incidenti che possono capitare alle figure di attaccamento e per gli eventi che possono portare alla perdita o separazione da esse. La persona è riluttante ad allontanarsi dalle figure di attaccamento; si possono presentare incubi e sintomi fisici di disagio.
- L’esordio avviene tipicamente in età infantile, ma può presentarsi anche in età adulta.
Mutismo selettivo
- La persona si mostra costantemente incapace di parlare in situazioni sociali in cui ci si aspetta che parli, ad es. a scuola;
- L’individuo è in grado di parlare in altre situazioni, ad es. a casa;
- Questa incapacità ha conseguenze sul rendimento in contesti educativi e lavorativi o interferisce con la normale comunicazione sociale.
Fobia specifica
- La persona si mostra spaventata o ansiosa rispetto ad un oggetto o situazione specifica e può mettere in atto comportamenti di evitamento di quegli oggetti o situazioni.
- La paura, l’ansia e l’evitamento sono quasi sempre scatenati immediatamente dalla situazione fobica e si presentano con un’intensità, ed una durata sproporzionati rispetto al reale rischio che essa rappresenta.
- L’autonomia e lo spazio di vita dell’individuo possono vedersi notevolmente ridotti dai sintomi.
- Vengono classificate diverse fobie specifiche in funzione dell’oggetto: animali, ambienti naturali, sangue-infezioni-ferite, situazionali, altre situazioni.
Disturbo d’ansia sociale (fobia sociale)
- Le situazioni che suscitano paura, ansia e vengono evitate sono quelle in cui la persona può essere sottoposta a giudizio o esame.
- Si può trattare di situazioni in cui si incontrano persone sconosciute, oppure in cui bisogna mangiare o bere in presenza d’altri, o in cui la persona si espone di fronte ad altri.
- Il pensiero che spaventa, in questo caso, è di essere valutato negativamente da altri, di essere imbarazzato, umiliato o rifiutato, oppure di offendere gli altri.
Disturbo di panico
- La persona sperimenta ricorrenti attacchi di panico inaspettati.
- L’individuo è costantemente preoccupato o spaventato di avere ulteriori di attacchi di panico oppure modifica il proprio comportamento in modo disadattivo a causa di essi, ad es. può evitare le occasioni in cui fare esercizio fisico o di andare in luoghi sconosciuti.
- Attacco di panico: comparsa improvvisa di sintomi di paura e disagio di intensità massima che raggiungono il picco in pochi minuti, poi si esauriscono in breve tempo. Possono prevalere i sintomi fisici o psichici dell’ansia.
- Attacchi di panico possono essere attesi, cioè si presentano in situazioni tipicamente temute, oppure inaspettati, nel caso in cui si presentino senza una ragione evidente.
Agorafobia
- Sono molteplici le situazioni che spaventano o suscitano ansia: stare in spazi aperti, utilizzare trasporti pubblici, stare in spazi ristretti, fare la fila, essere in mezzo alla folla, essere fuori casa da soli in altre situazioni.
- La persona teme queste situazioni perché pensa che potrebbe essere difficile fuggire oppure ricevere soccorso qualora ne abbia bisogno perché potrebbe sviluppare sintomi simili al panico, sintomi invalidanti o imbarazzanti.
- La persona generalmente evita le situazioni che suscitano ansia o vi si avvicina solo se accompagnata da una persona fidata.
Disturbo d’ansia generalizzato
- La persona prova ansia e preoccupazione persistenti ed eccessive rispetto a diversi ambiti della propria vita, tra cui anche quello lavorativo e scolastico.
- Fa difficoltà a controllare e gestire la propria ansia.
- Sono presenti sintomi fisici, tra cui irrequietezza, sensazione di agitazione o tensione, facile affaticamento, difficoltà di concentrazione o vuoti di memoria, irritabilità, tensione muscolare, disturbi del sonno.
Quali strategie per gestire l’ansia?
Se è vero che entro certi livelli l’ansia può essere considerata normale e addirittura funzionale ad affrontare alcue situazioni, può però essere utile conoscere alcune strategie per gestire l’ansia quando la si sente nascere, così da prevenire una sua crescita eccessiva che può portare ad un malessere significativo. Alcune di queste strategie possono essere:
- Esercizi di respirazione, come ad es. la respirazione diaframmatica.
- Tecniche di rilassamento, come il rilassamento muscolare progressivo, il training autogeno, ecc.
- Pratiche di mindfulness, che grazie all’incremento della consapevolezza offrono la possibilità di migliorare la capacità di gestire le emozioni.
- Esercizi di respirazione per gestire i sintomi acuti d’ansia, primo fra tutti un esercizio chiamato dell’arciere.
- Attività sportiva aerobica, praticata regolarmente migliora il benessere della persona e permette di incanalare l’attivazione e le energie in eccesso derivanti dalla reazione d’allarme.
- Stile di vita salutare, comprendente un’alimentazione equilibrata, una buona igiene del sonno, attività fisica praticata regolarmente, contribuisce a migliorare lo stato di salute della persona e previene l’insorgere di disturbi d’ansia.
- Relazioni interpersonali positive, che consentano alla persona di percepire la vicinanza ed il sostegno di persone fidate, contribuiscono a migliorare la sua capacità di fare fronte alle situazioni critiche e di gestire le proprie emozioni.
Quali prospettive terapeutiche?

Quando l’ansia cresce fino a diventare un ostacolo o una fonte di importante malessere nella vita della persona, può essere utile prendere in considerazione l’ipotesi di chiedere un aiuto specialistico, che consenta di prendersi cura di sé e della propria sofferenza, per tornare a sentirsi in equilibrio e riconquistare una qualità di vita soddisfacente.
In genere per prendersi cura di un malessere connesso all’ansia può essere utile rivolgersi ad uno/a psicoterapeuta, professionista specializzato/a nei trattamenti dei disturbi d’ansia.
Accanto al percorso di psicoterapia, può essere utile rivolgersi ad uno/a psichiatra, che valuti l’eventuale opportunità di prescrivere una terapia psicofarmacologica che aiuti a gestire gli stati d’ansia più acuti ed invalidanti.
Per quanto riguarda i percorsi psicoterapeutici, possiamo individuare due vie dimostratesi efficaci nella cura dei sintomi ansiosi. La prima consiste nell’intraprendere un percorso psicoterapeutico, individuale o di famiglia, che può aiutare a prendersi cura della sofferenza della persona e a stimolare le risorse di cui questa dispone per prendersi cura di sé. La seconda consiste nell’utilizzo clinico della mindfulness che, mediante percorsi individuali o di gruppo, aiuta la persona a coltivare quelle risorse e quelle capacità che le permettono di accogliere e gestire in modo più efficace le proprie emozioni e quindi prendersi cura della propria sofferenza e coltivare il proprio benessere.
La psicoterapia individuale o familiare, in particolare, può aiutare a:
- Rintracciare un senso al sintomo, dare un significato al proprio malessere in base alla propria storia di vita
- Migliorare la propria capacità di osservare le proprie sensazioni, emozioni e pensieri, riflettere su di essi e gestirli (competenze metacognitive)
- Incrementare la capacità di stare nelle situazioni stressanti e di gestirle con efficacia
- Incrementare la flessibilità psicologica, sviluppando strategie alternative a quelle automatiche di attacco-fuga
- Migliorare l’autostima e rafforzare la propria immagine di sè
- Migliorare le competenze relazionali e la qualità delle relazioni in cui si è coinvolti
- Migliorare la progettualità, potendo rivolgersi al futuro con sguardo fiducioso e non con ansia
L’utilizzo clinico della mindfulness consente di:
- Migliorare la propria capacità di tollerare ed affrontare situazioni stressanti e di gestire le emozioni spiacevoli (ampliare la finestra di tolleranza allo stress)
- Incrementare la flessibilità psicologica: nelle situazioni difficili aiuta a non dare risposte automatiche ed impulsive ma elaborare risposte funzionali alla situazione
- Accrescere la consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche, delle proprie difficoltà e risorse
- Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione: si impara a concentrare l’attenzione sul momento presente, senza seguire in modo automatico la cascata di pensieri ansiosi
- Coltivare un atteggiamento di sospensione del giudizio, di gentilezza e pazienza verso se stessi e verso l’altro
Bibliografia
- American Psychiatric Association (2014), DSM-5 Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali Quinta Edizione, Milano, R. Cortina Editore
- Bara B.G. (2006), Nuovo manuale di psicoterapia cognitiva, Torino, Bolalti Boringhieri
- Damasio A. (2000), Emozione e coscienza, Adelphi, Milano
- Goleman D. (1995), Intelligenza emotiva. Che cos’è. Perché può renderci felici, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano
- Kabat-Zinn J. (2016), Vivere momento per momento, Corbaccio
- LeDoux J.E. (2014), Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, Baldini & Castoldi, Milano [1998]
Contatti
Chiama
Scrivi
Mi trovi in