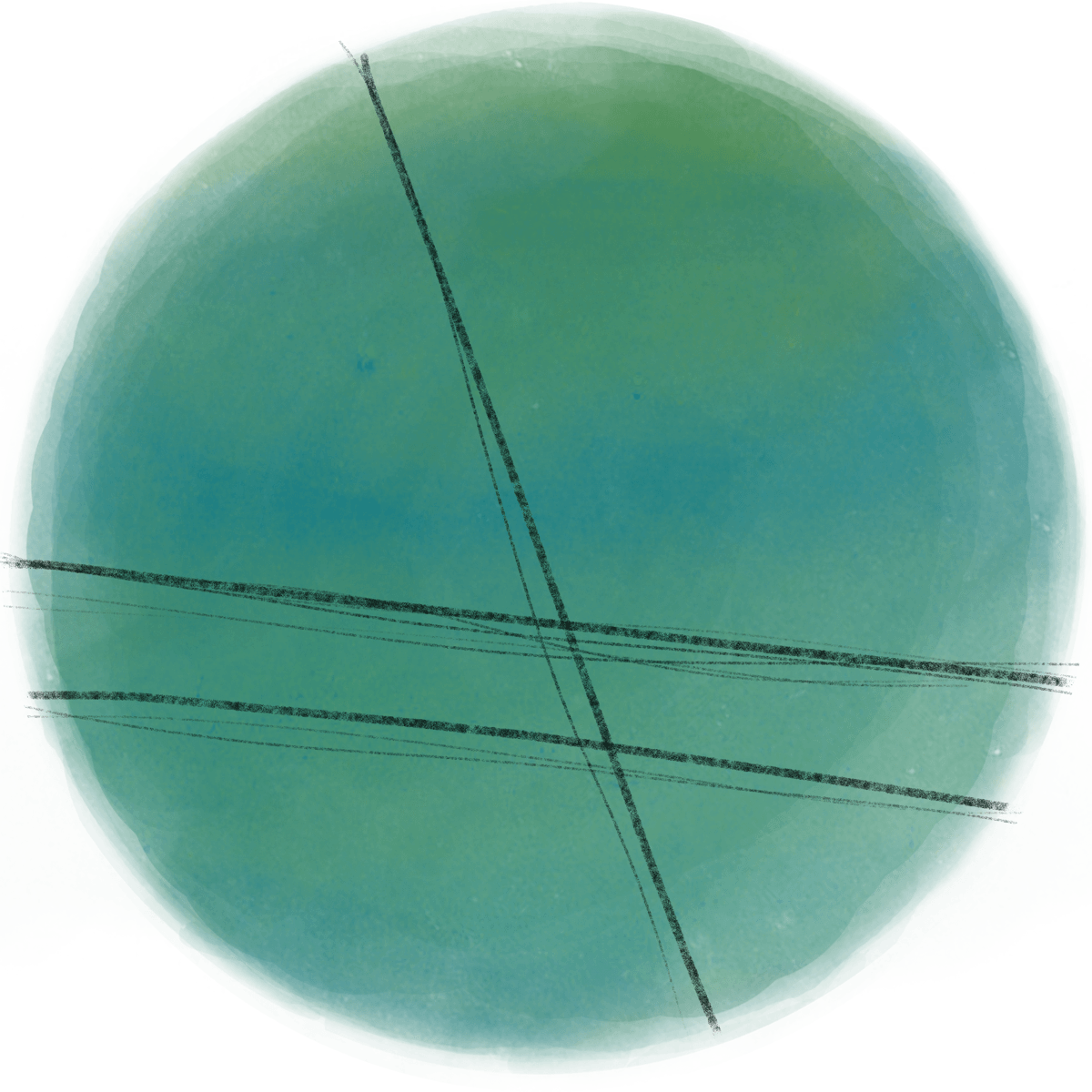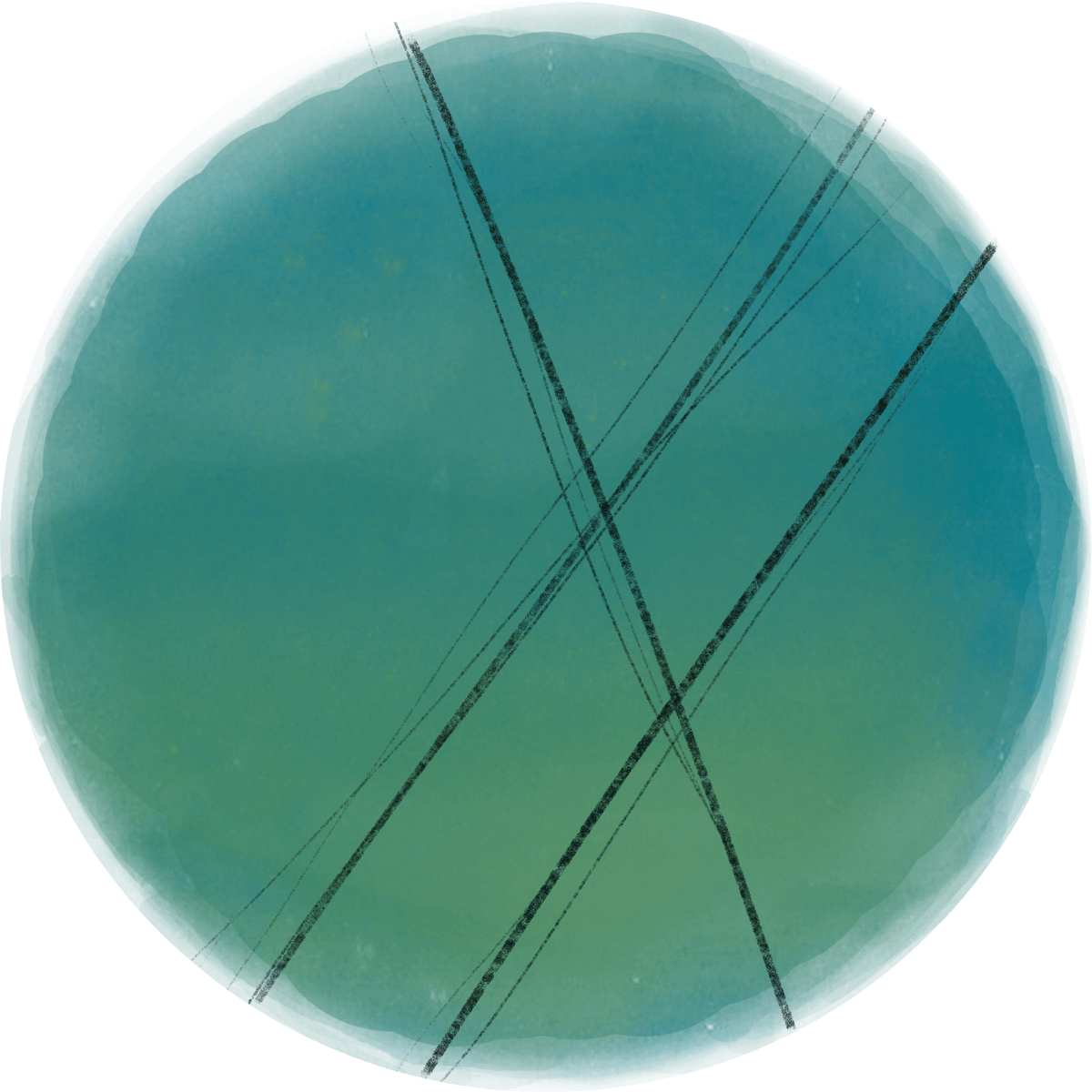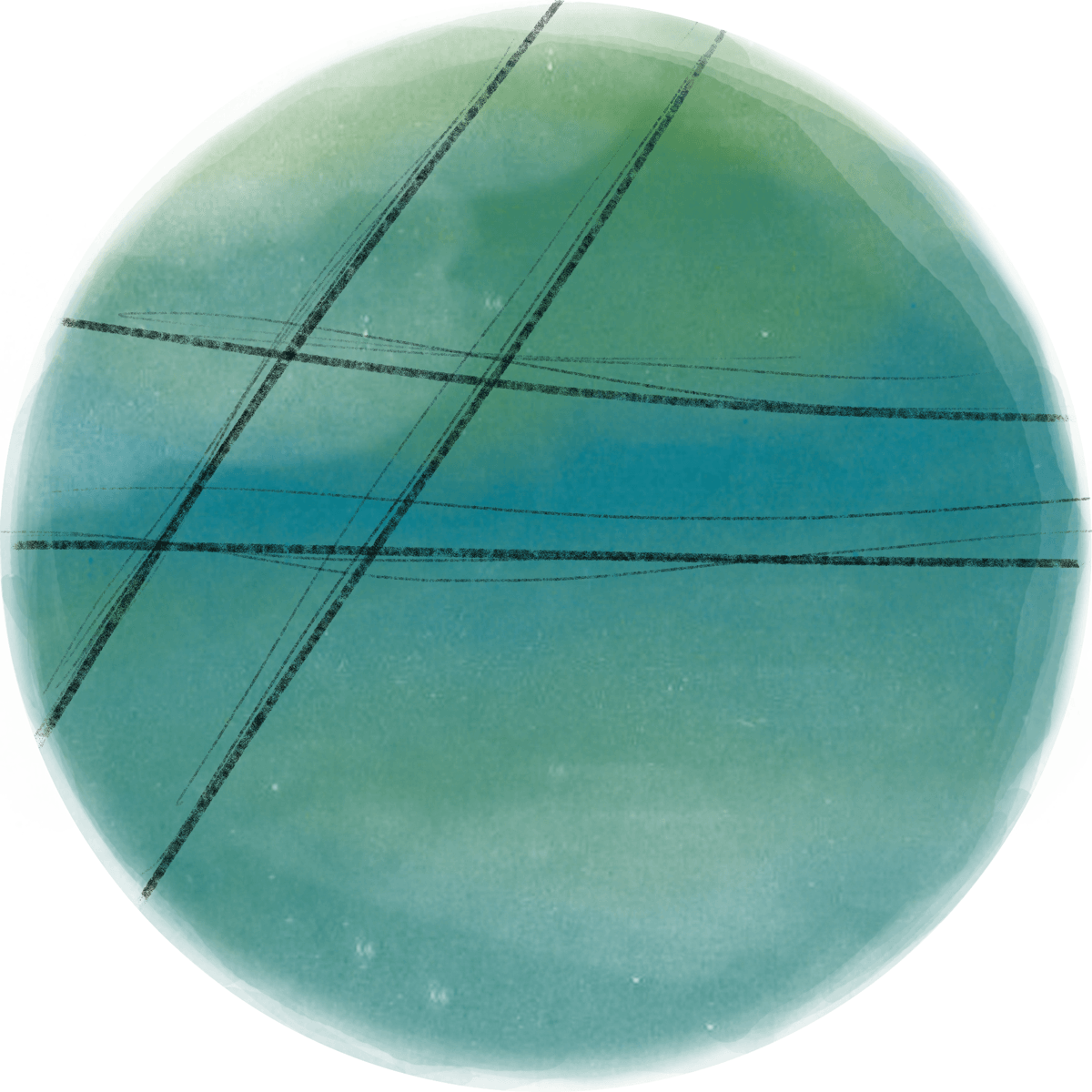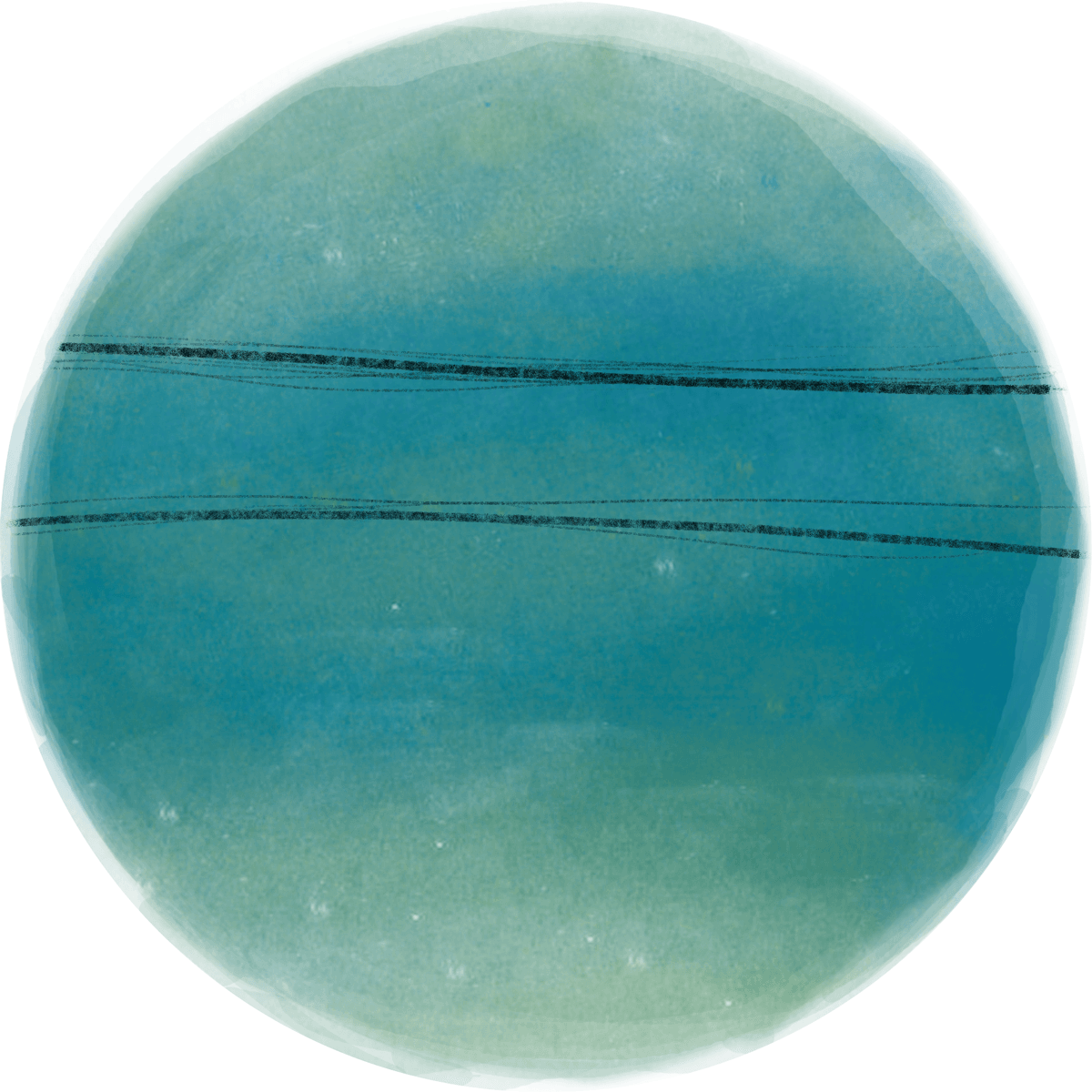8 Ottobre 2019
Mindfulness, il benessere nel momento presente
Negli ultimi anni si sente spesso parlare di mindfulness e si moltiplicano le proposte di attività di questo tipo. Come mai? E di che cosa si tratta?
L’obiettivo di questo articolo è proprio descrivere con termini quanto più possibile semplici che cos’è la mindfulness, una pratica di consapevolezza che può aiutare le persone a coltivare il proprio benessere e prendersi cura di sé.

Ma come mai si sta diffondendo così tanto e perché può essere utile lasciarsi incuriosire da questa attività?
Una delle buone ragioni può risiedere nel fatto che sempre più spesso ci muoviamo in un mondo frenetico, in cui siamo continuamente immersi in una molteplicità di stimoli, un mondo in cui prevale un clima di incertezza, di insicurezza e di giudizio. Questo ci espone al rischio di sviluppare una certa tensione, di vivere in uno stato di allarme e di stress persistente, che a lungo termine può suscitare un disagio profondo e danneggiare la nostra salute psicofisica. La mindfulness si propone come uno strumento prezioso, capace di alimentare la resilienza delle persone, rendendole capaci di attingere alle proprie buone risorse interiori per affrontare le difficoltà che la vita può riservare e per coltivare giorno dopo giorno un equilibrio emotivo che consenta di sentirsi sufficientemente bene con se stessi e con l’altro.
Che cos’è la mindfulness?
Un primo passo utile per rispondere a questa domanda consiste nel comprendere il significato del termine, parola inglese che solitamente non viene tradotta in italiano perché manca nella nostra lingua un termine che ne rappresenti efficacemente le varie sfumature di significato. Letteralmente la parola mindfulness significa “consapevolezza, attenzione cosciente”; nel contesto della psicologia, però, con questo termine ci si riferisce ad una piena presenza mentale, ad uno stato di coscienza connotato dalla capacità di concentrare consapevolmente l’attenzione sull’esperienza (fisica, emotiva e mentale) che si sta facendo nel qui ed ora. Uno stato di coscienza caratterizzato inoltre da un atteggiamento di apertura, che potenzialmente può dare grandi benefici a colui o colei che la coltiva in termini di benessere fisico e psicologico.
La pratica di mindfulness, che larga diffusione ha avuto negli ultimi decenni nel panorama occidentale, è stata ideata alla fine degli anni ’70 del secolo scorso da un medico statunitense, Jon Kabat-Zinn, e dal suo gruppo di studio presso l’Università della Massachussets Medical School. Tuttavia affonda le radici in una pratica assai più antica, quella della tradizione di meditazione Buddhista, che Kabat-Zinn ha conosciuto a livello esperienziale e studiato mediante ricerche scientifiche. Percorso che gli ha consentito di creare la mindfulness, pratica di consapevolezza laica e coerente con il contesto culturale occidentale di cui sono da tempo note le potenzialità e l’efficacia nel migliorare lo stato di salute e la qualità di vita in coloro che la praticano.
Con il termine mindfulness oggi possiamo indicare sia uno stato di coscienza particolare, sia un insieme di pratiche (o esercizi) grazie a cui possiamo coltivare quello stato mentale.
In quanto stato di coscienza, la mindfulness consiste nella possibilità di concentrare intenzionalmente un’attenzione consapevole sulla propria esperienza nel momento presente, ossia su ciò che in prima persona si prova nel qui ed ora in termini di sensazioni e stati fisici, di esperienza emotiva e in generale di esperienza mentale. Si tratta di un’attenzione aperta, libera da valutazioni e da giudizi, capace di osservare ciò che accade nel proprio corpo e nell’ambiente circostante accogliendolo così com’è.
Se è vero che la mindfulness consiste in primo luogo nella possibilità di allenare questo tipo particolare di attenzione a concentrarsi sull’esperienza del momento presente, è altresì vero che limitarsi semplicemente a questo sarebbe un po’ riduttivo. Infatti, altro elemento centrale della pratica di mindfulness è l’atteggiamento con cui ci si può avvicinare alla pratica e che la pratica stessa contribuisce a coltivare. Si tratta di un atteggiamento basato su alcuni principi, che Kabat-Zinn chiama i pilastri della mindfulness.
È importante coltivare durante la pratica un atteggiamento non giudicante, cioè la possibilità di osservare e riconoscere i giudizi che la nostra mente produce su tutto ciò che accade in noi e attorno e la possibilità di assumere la posizione di osservatore imparziale nei confronti della propria attività mentale ed esperienza fisica ed emotiva.
Per fare mindfulness e grazie alla pratica è possibile coltivare un atteggiamento paziente, nei confronti di sé stesso e in generale; si tratta di una qualità che consente di darsi e dare il tempo perché le cose ed i cambiamenti maturino, così come è necessario fare con la crisalide che, quando il tempo è maturo, può trasformarsi e dare vita alla farfalla.
Altro aspetto fondamentale è la capacità di coltivare un atteggiamento di curiosità ed apertura nei confronti di ciò che può accadere momento per momento, grazie a cui la persona può decidere di rapportarsi ad ogni cosa come se la vedesse la prima volta, e ad ogni momento come un momento unico ed irripetibile, ricco di potenzialità da scoprire.
Praticare la mindfulness consente, inoltre, di coltivare la possibilità di fidarsi in primo luogo di se stessi, della propria esperienza, di ciò che il proprio corpo e la propria mente dicono e fanno. Questo permette di utilizzare le proprie esperienze come una bussola che indica il cammino da percorrere per realizzare se stessi.
Altro aspetto centrale quando si pratica la mindfulness consiste nell’opportunità di sospendere le proprie aspettative nei confronti di se stessi e della pratica. Ciò significa che è utile disporsi in ascolto di ciò che accade dentro e attorno a sé senza cercare risultati, ma con un atteggiamento curioso e aperto, il solo modo in cui la mindfulness può effettivamente far guadagnare risultati in termini di maggior consapevolezza e benessere.
Praticando la mindfulness è inoltre possibile coltivare un atteggiamento di accettazione nei confronti di ciò che accade in sé ed al di fuori. Questo non significa approvare qualsiasi cosa, più o meno condivisibile. Accettare significa poter osservare le cose così come sono nel momento presente, senza un immediato bisogno di respingerle, significa riuscire ad osservare se stessi e le proprie qualità così come sono ora. Questo, in realtà, è il primo passo che rende poi possibile ogni cambiamento consapevole.
Grazie alla mindfulness, infine, è possible imparare a lasciare andare, cioè permettere alla nostra mente di non attaccarsi ad alcuni aspetti della propria esperienza (come quando desidereremmo che i momenti di felicità fossero eterni e stiamo male perché questo non è realizzabile) e non respingerne automaticamente altri (pensiamo alle volte in cui tendiamo ad evitare alcune azioni che suscitano emozioni spiacevoli in noi, precludendoci la possibilità di risolvere una situazione critica).
Come fare mindfulness?
La via suggerita dalla mindfulness per accrescere la propria consapevolezza passa in primo luogo attraverso l’ascolto delle proprie esperienze corporee, focalizzando l’attenzione a concentrarsi sull’ascolto del respiro nel suo ritmo spontaneo e delle sensazioni corporee, in particolare le sensazioni di contatto con le superfici che sostengono il proprio corpo. Oltre a questo, si coltiva la capacità di osservare le proprie esperienze emotive così come sono momento dopo momento, migliorando via via la capacità di comprenderle e tollerarle. Per quanto riguarda l’attività mentale, cioè il lavorio incessante del pensiero dentro di noi, la mindfulness suggerisce di osservare quando questo distrae dall’obiettivo di ascoltare le proprie sensazioni ed emozioni, per poi tornare a focalizzare su questi aspetti la propria attenzione.
Concretamente, si può fare mindfulness integrando nella propria quotidianità una serie di esercizi, chiamati “pratiche”. Si distinguono di solito due tipi di pratiche.
Il primo consiste nelle pratiche formali, in cui la persona si ritaglia un tempo ed uno spazio, possibilmente tranquillo, in cui dedicarsi alla mindfulness. In una posizione seduta, eretta o sdraiata, è possibile seguire le indicazioni di una voce guida (dal vivo o registrata) che suggerisce via via ciò su cui focalizzare la propria attenzione e rispetto a cui rimanere in ascolto.
Si possono poi svolgere le pratiche informali, che suggeriscono di scegliere un’attività semplice che si svolge abitualmente nel quotidiano (come ad esempio lavarsi i denti, aprire la porta, farsi la doccia o mangiare un piccolo spuntino) e provare a svolgere questa attività concentrando la propria attenzione al 100% sulle sensazioni ed i vissuti emotivi che questa attività comporta, tentando di non distrarsi rincorrendo i pensieri che inevitabilmente possono nascere.
Come si vede, la pratica di mindfulness si presta ad essere integrata in vari modi nella quotidianità di ciascuno di noi. Sebbene all’inizio sia molto utile se non indispensabile una guida esperta (fare mindfulness è semplice ma non è facile), è imprescindibile fin dall’inizio un certo impegno personale e la disponibilità a mettersi in gioco nell’imparare un modo nuovo per osservare la propria esperienza.
L’impegno personale si può tradurre in una maggior efficacia della mindfulness come strumento grazie al quale coltivare il proprio benessere, i cui effetti sono maggiori se la persona ogni giorno dedica una porzione di tempo alla pratica in autonomia.
Perché fare mindfulness?
Il principale vantaggio dell’introdurre la pratica di mindfulness nella propria vita quotidiana consiste indubbiamente nella possibilità di riconoscere quando in noi è attivo il pilota automatico e nell’opportunità di scegliere di sganciarlo.

Che cosa vuol dire questo? Pensiamo a tutte le volte in cui lungo le nostre giornate facciamo le cose automaticamente: entriamo in una camera, poi ad un certo punto ci fermiamo e ci chiediamo come mai siamo andati proprio lì, per poi ricordarci che dovevamo prendere quella cosa; ci dirigiamo a lavoro in auto e mentre guidiamo pensiamo a tutto ciò che dobbiamo fare lungo la giornata e a cosa potrebbe accadere, senza fare caso al paesaggio attorno a noi; ci facciamo una doccia o mangiamo uno spuntino senza assaporare le sensazioni potenzialmente piacevoli di queste azioni, ma continuiamo a pensare a cosa è successo al lavoro o a quella discussione avuta con quella persona.
Tutto questo avviene perché abbiamo la capacità di apprendere delle azioni anche complesse e di memorizzare le procedure con cui portare a compimento le stesse. Questo ci permette di svolgerle con una certa sicurezza e senza bisogno di concentrare su esse la totalità della nostra attenzione, che così in parte si libera e si può dedicare ad altro.
In questo consiste il pilota automatico, nel riuscire a svolgere automaticamente alcune azioni in determinate circostanze mentre la nostra mente è impegnata in altri pensieri o progetti.
La possibilità di avvalersi del pilota automatico può essere un’ottima risorsa: ci permette di imparare a guidare un veicolo agilmente e rapidamente senza dover pensare e pianificare consapevolmente ogni minima azione, in molte circostanze ci permette di fare due cose contemporaneamente, come quando mentre guidiamo affrontiamo un’interessante discussione con il passeggero che ci accompagna. Ed ovviamente avvalersi del pilota automatico può fare risparmiare molto tempo.
Ci sono, però, situazioni in cui l’attività del pilota automatico non è così vantaggiosa per l’individuo. Pensiamo a tutte quelle volte in cui in determinate situazioni reagiamo in modo impulsivo anche se non vorremmo, o a quando magari facciamo un errore ed in modo assolutamente automatico si innescano una serie di giudizi negativi su noi stessi che non sono utili ma non riusciamo a fermare magari per ore o addirittura giorni. O pensiamo a quando, tornati a casa da lavoro, la nostra mente in modo automatico continua a pianificare o a cercare di risolvere problemi lavorativi senza permetterci di staccare, risposarci ed assaporare i momenti di svago e relax.
In tutte queste situazioni la mindfulness può essere un buon alleato: tornare con l’attenzione al respiro e alla propria esperienza corporea ed emotiva permette di imparare a rallentare e lasciare andare i pensieri, prendere consapevolezza di ciò che si sta muovendo in sé e soprattutto permette di scegliere su cosa concentrare la propria attenzione nel qui ed ora, dandoci l’opportunità di scegliere cosa assaporare nel momento presente: è utile continuare a pianificare e seguire i pensieri? Oppure è più utile concedersi una pausa ed assaporare i momenti piacevoli di relax insieme alle persone care?
Per come funziona la nostra mente, dotata di un potente pilota automatico, e per la frenesia che la nostra società ci impone oggi, rischiamo di vivere la nostra vita costantemente proiettati nel futuro o nel passato: ideiamo continuamente progetti, pianifichiamo, elaboriamo teorie, ripensiamo ad errori, incidenti o equivoci del passato. Rischiamo così di trascorrere la maggior parte della nostra esistenza senza riuscire a vivere davvero il momento presente: può essere molto complesso assaporare davvero ciò che viviamo nel qui ed ora, gioire delle piccole grandi conquiste di oggi, sentirci davvero liberi di scegliere cosa ci piacerebbe fare in questo momento.
La mindfulness può aiutarci a distogliere anche solo per un attimo l’attenzione dal passato e dal futuro e focalizzarla su ciò che stiamo sperimentando ora. Ci dà l’opportunità di riconoscere gli automatismi che tendono a guidare le nostre scelte ed azioni, dandoci così la preziosa opportunità di operare una scelta più consapevole: questo automatismo mi è utile? Preferisco seguirlo oppure preferisco interromperlo e scegliere un’altra via?
È così che fare mindfulness con una certa costanza e con impegno ci permette di imparare ad assaporare i vari momenti della nostra vita, facendo spazio non solo per ciò che di difficile accade, ma anche per i momenti di gioia, spensieratezza e leggerezza. Ed è così che la mindfulness permette di coltivare un senso di libertà interiore, una libertà di scelta assai importante per il proprio benessere personale.
Quali effetti ha la mindfulness?
Negli ultimi decenni sono state condotte molte ricerche scientifiche per testare quale sia l’efficacia della mindfulness, quali benefici essa può apportare a livello fisiologico, nello stato di salute (fisica ed emotiva) e nella percezione di benessere di chi la pratica. Si è osservato che questi sono molteplici e possono riguardare vari ambiti della vita di ciascuno.
I benefici della mindfulness vengono veicolati dal fatto che essa offre l’opportunità di essere più consapevoli di ciò che accade in noi momento dopo momento: essere maggiormente in contatto con i propri stati interiori, riuscire ad osservarli liberi dal giudizio e con atteggiamento benevolo è il primo passo che ci permette di intraprendere un percorso per prenderci cura di noi stessi e cercare di cambiare gli aspetti migliorabili.
Una miglior consapevolezza ed osservazione dei propri stati interni ha l’effetto di rendere più tollerabili per la persona che li vive i propri sentimenti, le emozioni e tutte le sensazioni fisiche ad essi connesse: rimanere in contatto con tali fenomeni permette di conoscerli meglio e non lasciarsene spaventare così facilmente, e consente di imparare a gestire le proprie emozioni per renderle un alleato nelle varie situazioni della vita personale, relazionale e professionale.
Di conseguenza grazie alla pratica di mindfulness sarà più facile gestire le situazioni stressanti, cioè quelle situazioni che mettono alla prova e fanno sentire sotto pressione. La persona potrà affrontare le situazioni difficili con maggior lucidità e minore allarme, riuscendo a distinguere le proprie reazioni, aspettative e giudizi, distinguendo inoltre ciò che è controllabile e ciò che non lo è. E sarà più facile, in condizioni di stress, scegliere una strategia utile a risolvere il problema che si trova di fronte e decidere di non avvalersi di strategie che non avvicinano ad una soluzione vantaggiosa, anzi potrebbero danneggiare la propria salute (si pensi a quante volte, in situazioni di stress e mossi da un’emotività difficilmente gestibile , ricorriamo ad esempio all’abuso di sostanze o di farmaci oppure ad abitudini alimentari non salutari).
Numerose ricerche hanno descritto, inoltre, come praticare la mindfulness aiuti a ridurre e rendere più tollerabili le sensazioni e i sintomi d’ansia: l’ansia è un’emozione che chiunque può sperimentare ripetutamente lungo la propria esistenza; in alcune circostanze le emozioni di paura e di ansia sono comprensibili e motivate, ma talvolta l’ansia diventa tanto forte da suscitare profondo malessere ed ostacolare la persona nello svolgimento delle proprie attività abituali. In questi casi, praticare la mindfulness aiuta a prendere una miglior consapevolezza di se stessi e delle proprie sensazioni (quelle connesse all’ansia e non), aiuta a rendere più tollerabili le emozioni e sensazioni d’ansia, che diventano così meno invalidanti, e permette di fare spazio anche ad altri sentimenti offrendo così la possibilità di rendere la propria vita più ricca di sfumature.
Molti studi hanno inoltre dimostrato che praticare mindfulness quotidianamente può contribuire a migliorare la salute di coloro che hanno una storia di depressione, in particolare aiutando la persona a individuare ed allentare quella cascata di pensieri negativi che la depressione comporta, aiutando a coltivare un atteggiamento più gentile e compassionevole nei propri confronti e prevenendo quindi le ricadute in episodi depressivi che tanto dolore suscitano nell’individuo.

Vi sono, inoltre, numerose ricerche scientifiche che dimostrano come la pratica quotidiana della mindfulness possa apportare significativo giovamento in tutte quelle situazioni in cui patologie organiche, spesso croniche, causano disagio e dolore che vanno ad alterare la qualità di vita della persona coinvolta. Si tratta di situazioni in cui spesso coesistono sensazioni di dolore organico più o meno intenso e duraturo, ma comunque stressante, con emozioni assai difficili di paura, rabbia, tristezza, delusione, ansia, angoscia, depressione. In questi casi, ricorrere alla mindfulness può essere un valido strumento per rendere la persona più capace di tollerare le sensazioni di dolore (molto importante nel caso di dolori cronici che non possono essere curati con strumentazioni mediche), ma soprattutto è un ottimo strumento per lenire il malessere ed il disagio emotivo che la patologia organica suscita.
Bibliografia
- Bertino, G. (2011). Meditazioni. Dalla mindfulness una via pratica per la salute del corpo e della mente. In Ecomind (Eds.)
- Blanck, P., Perleth, S., Heidenreich, T., Kröger, P., Ditzen, B., Bents, H., et al. (2018). Effects of mindfulness exercises as stand-alone intervention on symptoms of anxiety and depression: Systematic review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy, 102, 25-35.
- Bohlmeijer, E., Prenger, R., Taal, E., & Cuijpers, P. (2010). The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 68(6), 539-544.
- Carvalho, S. A., Gillanders, D., Palmeira, L., Pinto‐Gouveia, J., & Castilho, P. (2018). Mindfulness, selfcompassion, and depressive symptoms in chronic pain: The role of pain acceptance. Journal of Clinical Psychology.
- Cash, E., Salmon, P., Weissbecker, I., Rebholz, W., Bayley-Veloso, R., Zimmaro, L., et al. (2015). Mindfulness Meditation Alleviates Fibromyalgia Symptoms in Women: Results of a Randomized Clinical Trial. [Article]. Annals of Behavioral Medicine, 49(3), 319-330.
- Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2017). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. In B. A. Gaudiano (Ed.), Mindfulness: Clinical applications of mindfulness and acceptance: Specific interventions for psychiatric, behavioural, and physical health conditions. (pp. 451-480). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.
- Kabat-Zinn, J. (2017). Dovunque tu vada ci sei già. Capire la ricchezza del nostro presente per iniziare il cammino verso la consapevolezza: Corbaccio.
- Kabat-Zinn, J. (2018). Vivere momento per momento. Sconfiggere lo stress, il dolore, l’ansia e la malattia con la mindfulness (A. Sabbadini, Trans.). Milano: TEA.
- Merkes, M. (2010). Mindfulness-based stress reduction for people with chronic diseases. Aust J Prim Health, 16(3), 200-210.
- Vøllestad, J., Nielsen, M. B., & Nielsen, G. H. (2012). Mindfulness‐ and acceptance‐based interventions for anxiety disorders: A systematic review and meta‐analysis. British Journal of Clinical Psychology, 51(3), 239-260.
Contatti
Chiama
Scrivi
Mi trovi in